Nonostante i dazi e il freno all’immigrazione, agli USA rimangono debito pubblico fuori controllo e crescita dipendente dallo stimolo fiscale. Brevi i margini di manovra fiscale e monetaria.
di Maurizio Novelli, Gestore del fondo Lemanik Global Strategy
I mercati attribuiscono alla vittoria di Trump un effetto taumaturgico che difficilmente potrà durare nel tempo, poichè quello che è importante non sono le promesse elettorali ma i reali margini di manovra che questa amministrazione avrà a disposizione veramente. Trump eredita una economia che, dal 2021, produce un deficit di 8 punti di Pil all’anno per ottenere in cambio un Pil nominale di 4 punti. È come se voi tutte le mattine usciste di casa per andare a lavorare spendendo 8 Euro al giorno per guadagnarne 4. Sebbene gli operatori di Wall Street credono ciecamente che il cambio di amministrazione possa risolvere i problemi, appare alquanto complicato credere che tali problemi possano essere risolti senza sacrifici tangibili.
 La nomina di Bessent al ministero del Tesoro è una scelta molto azzeccata: 1) è un macro portfolio manager proveniente dal mondo degli hedge funds esperto in economia monetaria e finanza, 2) è un forte critico della sciagurata gestione Yellen, sia alla Fed che al Tesoro, 3) è contrario alle politiche di espansione della spesa pubblica fuori controllo, 4) è più preoccupato della “protezione” dei Treasuries e del dollaro che delle politiche di sostegno ad oltranza alla borsa, 5) è stato piuttosto acido nei confronti delle strategie monetarie della Fed attuate da Yellen e Powell, che si sono di fatto “supinate” alla Modern Monetary Theory (debito e money printing). Bessent sa perfettamente che il modello economico Usa è in crisi. Il problema di fondo è se il modo di pensare di Bessent è in linea con il modo di pensare di Trump, e se si verificheranno problemi di convergenza tra l’approccio di Trump e quello di Bessent sarà piuttosto complicato licenziare il Ministro del Tesoro senza avere pesanti ripercussioni su Treasury Bonds e dollaro.
La nomina di Bessent al ministero del Tesoro è una scelta molto azzeccata: 1) è un macro portfolio manager proveniente dal mondo degli hedge funds esperto in economia monetaria e finanza, 2) è un forte critico della sciagurata gestione Yellen, sia alla Fed che al Tesoro, 3) è contrario alle politiche di espansione della spesa pubblica fuori controllo, 4) è più preoccupato della “protezione” dei Treasuries e del dollaro che delle politiche di sostegno ad oltranza alla borsa, 5) è stato piuttosto acido nei confronti delle strategie monetarie della Fed attuate da Yellen e Powell, che si sono di fatto “supinate” alla Modern Monetary Theory (debito e money printing). Bessent sa perfettamente che il modello economico Usa è in crisi. Il problema di fondo è se il modo di pensare di Bessent è in linea con il modo di pensare di Trump, e se si verificheranno problemi di convergenza tra l’approccio di Trump e quello di Bessent sarà piuttosto complicato licenziare il Ministro del Tesoro senza avere pesanti ripercussioni su Treasury Bonds e dollaro.
 Mentre la nuova amministrazione entrerà in carica a fine gennaio, l’attuale traiettoria della spesa pubblica si appresta a bucare il deficit dell’8% nel 2024, ed è proiettato al 10% nel 2025 senza interventi di correzione. Il problema è che l’attuale composizione della spesa è particolarmente accentuata verso sussidi e assistenza per sostenere i consumi, riducendo la quale si potrebbero avere pesanti ricadute sulla domanda interna e sulla solvibilità del credito al consumo, aumentando radicalmente i rischi di una caduta dell’economia. In sostanza, il “mandatory spending“, cioè la spesa che non puoi toccare senza fare danni tangibili all’economia, assorbe ormai il 70% della spesa corrente.
Mentre la nuova amministrazione entrerà in carica a fine gennaio, l’attuale traiettoria della spesa pubblica si appresta a bucare il deficit dell’8% nel 2024, ed è proiettato al 10% nel 2025 senza interventi di correzione. Il problema è che l’attuale composizione della spesa è particolarmente accentuata verso sussidi e assistenza per sostenere i consumi, riducendo la quale si potrebbero avere pesanti ricadute sulla domanda interna e sulla solvibilità del credito al consumo, aumentando radicalmente i rischi di una caduta dell’economia. In sostanza, il “mandatory spending“, cioè la spesa che non puoi toccare senza fare danni tangibili all’economia, assorbe ormai il 70% della spesa corrente.
 L’opinione pubblica americana, contrariamente a Wall Street, non crede più ai dati macro, e la sconfitta di Biden ne è la prova. Avendo oggi il controllo di Senato e Camera, è probabile che le scelte di politica economica e di spesa pubblica, strada facendo, possano entrare in collisione tra il modo di pensare di Bessent, meno politico e più economico, e quello di Trump. Finora, bond e dollaro sono saliti perché danno per scontato che Bessent possa implementare la sua agenda: controllo della spesa, salvaguardia del dollaro e gradualità nell’introduzione dei dazi. Per quanto riguarda i dazi, è certo che la prima mossa di questa amministrazione sarà quella di mandare un serio segnale che l’America non scherza sulle politiche commerciali. Ci sarà quindi un primo round di imposizione di dazi a Cina, Europa, Messico e Canada, e poi si comincerà a parlare. Se questi paesi non si piegheranno alla volontà degli Stati Uniti ci saranno ulteriori conseguenze con dazi via via più elevati.
L’opinione pubblica americana, contrariamente a Wall Street, non crede più ai dati macro, e la sconfitta di Biden ne è la prova. Avendo oggi il controllo di Senato e Camera, è probabile che le scelte di politica economica e di spesa pubblica, strada facendo, possano entrare in collisione tra il modo di pensare di Bessent, meno politico e più economico, e quello di Trump. Finora, bond e dollaro sono saliti perché danno per scontato che Bessent possa implementare la sua agenda: controllo della spesa, salvaguardia del dollaro e gradualità nell’introduzione dei dazi. Per quanto riguarda i dazi, è certo che la prima mossa di questa amministrazione sarà quella di mandare un serio segnale che l’America non scherza sulle politiche commerciali. Ci sarà quindi un primo round di imposizione di dazi a Cina, Europa, Messico e Canada, e poi si comincerà a parlare. Se questi paesi non si piegheranno alla volontà degli Stati Uniti ci saranno ulteriori conseguenze con dazi via via più elevati.
 Non sarà facile ristrutturare il modello economico Usa senza pesanti sacrifici interni. Una vera ristrutturazione dell’economia comporterebbe un ridimensionamento dei monopoli tecnologici, maggiori tasse sul capitale, sulla finanza e sulla Corporate Usa, maggiori tasse sui redditi medio alti e minori tasse su famiglie a reddito inferiore ai 120.000 dollari. Queste scelte produrrebbero una migliore redistribuzione dei redditi, una riduzione del debito pubblico e una crescita economica più equilibrata, dato che attualmente i consumi della fascia media di reddito sono eccessivamente dipendenti dal debito al consumo, creando una crescita finanziata da debito a costi superiori al 20% all’anno e non sostenibili. Infatti, il 20% dei consumi interni Usa è finanziato dal credito al consumo a tassi del 24% annuo, il 73% del Pil dipende solo dai consumi interni, il 14% del Pil Usa dipende da consumi finanziati, i consumi Usa sono pari al 20% del Pil mondiale e quelli finanziati sono pari a circa il 3,75% del Pil mondiale. Un bel problema se l’America non continua a fare debito a questi ritmi.
Non sarà facile ristrutturare il modello economico Usa senza pesanti sacrifici interni. Una vera ristrutturazione dell’economia comporterebbe un ridimensionamento dei monopoli tecnologici, maggiori tasse sul capitale, sulla finanza e sulla Corporate Usa, maggiori tasse sui redditi medio alti e minori tasse su famiglie a reddito inferiore ai 120.000 dollari. Queste scelte produrrebbero una migliore redistribuzione dei redditi, una riduzione del debito pubblico e una crescita economica più equilibrata, dato che attualmente i consumi della fascia media di reddito sono eccessivamente dipendenti dal debito al consumo, creando una crescita finanziata da debito a costi superiori al 20% all’anno e non sostenibili. Infatti, il 20% dei consumi interni Usa è finanziato dal credito al consumo a tassi del 24% annuo, il 73% del Pil dipende solo dai consumi interni, il 14% del Pil Usa dipende da consumi finanziati, i consumi Usa sono pari al 20% del Pil mondiale e quelli finanziati sono pari a circa il 3,75% del Pil mondiale. Un bel problema se l’America non continua a fare debito a questi ritmi.
 Ma chi vuole veramente implementare un aggiustamento dell’economia verso una strada più sostenibile? La lobby di Wall Street non vuole tasse sul capitale e sulla finanza, né tantomeno sulla Corporate America, dato che questo farebbe scendere la borsa. Le banche americane lucrano colossali interessi sul credito al consumo erogato a tassi da usuraio e beneficiano sempre dei bail out in caso di crisi. Le basse tasse sulle grandi società quotate creano un gap di redditività delle aziende Usa verso quelle di Europa e Giappone, sostenendo l’equity americano che spende il 50% dei profitti annui in buy back. I monopoli tecnologici sono indispensabili per il controllo sociale e per la sicurezza informatica del paese, inoltre servono a sostenere la strategia geopolitica di controllo globale della tecnologia nel modo occidentale. Chi è disposto ad accettare un cambio di modello di crescita rinunciando ai privilegi attuali basati ormai solo sull’espansione della spesa pubblica?
Ma chi vuole veramente implementare un aggiustamento dell’economia verso una strada più sostenibile? La lobby di Wall Street non vuole tasse sul capitale e sulla finanza, né tantomeno sulla Corporate America, dato che questo farebbe scendere la borsa. Le banche americane lucrano colossali interessi sul credito al consumo erogato a tassi da usuraio e beneficiano sempre dei bail out in caso di crisi. Le basse tasse sulle grandi società quotate creano un gap di redditività delle aziende Usa verso quelle di Europa e Giappone, sostenendo l’equity americano che spende il 50% dei profitti annui in buy back. I monopoli tecnologici sono indispensabili per il controllo sociale e per la sicurezza informatica del paese, inoltre servono a sostenere la strategia geopolitica di controllo globale della tecnologia nel modo occidentale. Chi è disposto ad accettare un cambio di modello di crescita rinunciando ai privilegi attuali basati ormai solo sull’espansione della spesa pubblica?
 È quindi certo che l’attuale squilibrato modello di crescita Usa rimarrà tendenzialmente intatto finché non cederà perché insostenibile, solo a quel punto verrà preso atto che bisogna cambiare. Sono quindi molto scettico sulla possibilità di Bessent di poter incidere sulla traiettoria della politica fiscale ed economica: il debito continuerà a crescere sia a livello pubblico che privato e l’inflazione rimane una delle scelte più facili per svalutarlo in termini reali. L’America può cambiare solo quando il suo modello economico andrà in crisi, ma pur di difenderlo ad oltranza metterà in crisi il resto del mondo. Quindi la crisi da qualche parte la si deve subire, in particolare in Europa e Canada, in Giappone, in Cina e nei paesi Latam che intermediano troppo i prodotti cinesi verso gli Stati Uniti. Pertanto, il 2025 sarà un anno di difficoltà sia per l’economia mondiale che per l’agenda Trump. Si profila infatti un contesto di stagnazione globale mascherato da dati macro “massaggiati” in modo da non evidenziare una recessione e sostenere la teoria del soft landing (probabilmente infinito).
È quindi certo che l’attuale squilibrato modello di crescita Usa rimarrà tendenzialmente intatto finché non cederà perché insostenibile, solo a quel punto verrà preso atto che bisogna cambiare. Sono quindi molto scettico sulla possibilità di Bessent di poter incidere sulla traiettoria della politica fiscale ed economica: il debito continuerà a crescere sia a livello pubblico che privato e l’inflazione rimane una delle scelte più facili per svalutarlo in termini reali. L’America può cambiare solo quando il suo modello economico andrà in crisi, ma pur di difenderlo ad oltranza metterà in crisi il resto del mondo. Quindi la crisi da qualche parte la si deve subire, in particolare in Europa e Canada, in Giappone, in Cina e nei paesi Latam che intermediano troppo i prodotti cinesi verso gli Stati Uniti. Pertanto, il 2025 sarà un anno di difficoltà sia per l’economia mondiale che per l’agenda Trump. Si profila infatti un contesto di stagnazione globale mascherato da dati macro “massaggiati” in modo da non evidenziare una recessione e sostenere la teoria del soft landing (probabilmente infinito).
 Non si intravede, dunque, alcun cambiamento sensibile nella strategia di crescita Usa: spesa pubblica, dazi e freno all’immigrazione (che non incideranno più di tanto sulle problematiche strutturali attuali). Se guardiamo alle proposte di politica economica evidenziate da Trump, appare alquanto improbabile che si possa ottenere un controllo della spesa tramite i dazi e la riduzione ulteriore delle imposte, mentre una ulteriore deregulation non avrà impatti significativi sulla crescita poichè la deregulation è già ora parecchio accentuata: il Private Equity è passato da 1 Tr di dollari nel 2007 a oltre 9 Tr di dollari nel 2023; il Private Credit totalmente unregulated è in espansione a 1,8 Tr di dollari, lo Shadow Banking vale il 60% del credito all’economia, le Criptovalute esplodono grazie alla promessa di non regolamentazione e le banche Usa sono esenti da Basilea III.
Non si intravede, dunque, alcun cambiamento sensibile nella strategia di crescita Usa: spesa pubblica, dazi e freno all’immigrazione (che non incideranno più di tanto sulle problematiche strutturali attuali). Se guardiamo alle proposte di politica economica evidenziate da Trump, appare alquanto improbabile che si possa ottenere un controllo della spesa tramite i dazi e la riduzione ulteriore delle imposte, mentre una ulteriore deregulation non avrà impatti significativi sulla crescita poichè la deregulation è già ora parecchio accentuata: il Private Equity è passato da 1 Tr di dollari nel 2007 a oltre 9 Tr di dollari nel 2023; il Private Credit totalmente unregulated è in espansione a 1,8 Tr di dollari, lo Shadow Banking vale il 60% del credito all’economia, le Criptovalute esplodono grazie alla promessa di non regolamentazione e le banche Usa sono esenti da Basilea III.
 La trasformazione dell’America in un’economia manufatturiera è improbabile. L’unica cosa che può essere fatta è indurre i produttori esteri a trasferire parte della produzione in Usa per evitare i dazi. Vediamo se l’Europa o la Cina saranno così d’accordo ad accettare una disoccupazione più alta e recessione per sostenere queste richieste. Quest’ultima riflessione porta a pensare che il 2025 aprirà una fase di conflittualità economica globale che si sostituirà alla conflittualità geopolitica in corso. L’amministrazione Trump punta infatti a spostare il conflitto più sul piano economico che geopolitico, ma il primo è meglio del secondo perchè i danni collaterali della conflittualità economica sono mondiali e non solo regionali come negli attuali conflitti in corso.
La trasformazione dell’America in un’economia manufatturiera è improbabile. L’unica cosa che può essere fatta è indurre i produttori esteri a trasferire parte della produzione in Usa per evitare i dazi. Vediamo se l’Europa o la Cina saranno così d’accordo ad accettare una disoccupazione più alta e recessione per sostenere queste richieste. Quest’ultima riflessione porta a pensare che il 2025 aprirà una fase di conflittualità economica globale che si sostituirà alla conflittualità geopolitica in corso. L’amministrazione Trump punta infatti a spostare il conflitto più sul piano economico che geopolitico, ma il primo è meglio del secondo perchè i danni collaterali della conflittualità economica sono mondiali e non solo regionali come negli attuali conflitti in corso.
 L’Oro rimane per ora l’asset class che può offrire maggiore protezione in questo contesto. I titoli di debito Usa sono vulnerabili a serie difficoltà nell’implementare un vero controllo del deficit, e per stabilizzare la dinamica attuale del debito pubblico sarebbe necessario produrre almeno 3 punti di Pil di avanzo primario rispetto a un disavanzo primario attuale di 5 punti (avanzo e disavanzo primario sono al netto degli interessi passivi annuali sul debito). È un’operazione praticamente impossibile senza creare una pesantissima recessione e dire addio alle politiche fiscali espansive per Corporate Usa, finanza e Wall Street.
L’Oro rimane per ora l’asset class che può offrire maggiore protezione in questo contesto. I titoli di debito Usa sono vulnerabili a serie difficoltà nell’implementare un vero controllo del deficit, e per stabilizzare la dinamica attuale del debito pubblico sarebbe necessario produrre almeno 3 punti di Pil di avanzo primario rispetto a un disavanzo primario attuale di 5 punti (avanzo e disavanzo primario sono al netto degli interessi passivi annuali sul debito). È un’operazione praticamente impossibile senza creare una pesantissima recessione e dire addio alle politiche fiscali espansive per Corporate Usa, finanza e Wall Street.
 Il dollaro forte continuerà a reggere fino a quando Giappone ed Europa accetteranno la stagnazione imposta dagli Stati Uniti ai paesi che finanziano il debito Usa. Tali economie infatti devono costantemente aumentare il risparmio interno per dirottarlo poi verso gli asset americani, grazie al quale si finanzia così il leverage Usa e la finanza speculativa di Wall Street. Vediamo per quanto tempo le economie occidentali reggeranno questo modello, entrato ormai nella sua fase più estrema, dove l’America si sta posizionando come un’economia troppo finanziarizzata per avere un risparmio interno negativo. Il “Trump rally” sembra difficilmente sostenibile, e le prospettive per l’equity si fanno incerte, in particolare per l’Europa.
Il dollaro forte continuerà a reggere fino a quando Giappone ed Europa accetteranno la stagnazione imposta dagli Stati Uniti ai paesi che finanziano il debito Usa. Tali economie infatti devono costantemente aumentare il risparmio interno per dirottarlo poi verso gli asset americani, grazie al quale si finanzia così il leverage Usa e la finanza speculativa di Wall Street. Vediamo per quanto tempo le economie occidentali reggeranno questo modello, entrato ormai nella sua fase più estrema, dove l’America si sta posizionando come un’economia troppo finanziarizzata per avere un risparmio interno negativo. Il “Trump rally” sembra difficilmente sostenibile, e le prospettive per l’equity si fanno incerte, in particolare per l’Europa.



 Sebbene i tassi d’interesse siano ai massimi da vent’anni, la Cina sia afflitta da una bolla immobiliare e il suo principale partner commerciale, l’Europa, stia flirtando con la
Sebbene i tassi d’interesse siano ai massimi da vent’anni, la Cina sia afflitta da una bolla immobiliare e il suo principale partner commerciale, l’Europa, stia flirtando con la  Il bilancio dei consumatori americani sembra più stabile che mai, nonostante i terribili rendimenti finanziari del 2022 e la capacità di acquisto di un’abitazione vicina ai minimi storici. È interessante notare che quest’ultima ha colpito solo marginalmente il
Il bilancio dei consumatori americani sembra più stabile che mai, nonostante i terribili rendimenti finanziari del 2022 e la capacità di acquisto di un’abitazione vicina ai minimi storici. È interessante notare che quest’ultima ha colpito solo marginalmente il  I soft landing sono estremamente difficili da raggiungere. Il motivo è che le autorità agiscono osservando le ultime pubblicazioni di dati, i quali però si riferiscono al passato (Pil, disoccupazione,
I soft landing sono estremamente difficili da raggiungere. Il motivo è che le autorità agiscono osservando le ultime pubblicazioni di dati, i quali però si riferiscono al passato (Pil, disoccupazione,  un atterraggio morbido. Se guardiamo ai casi passati di
un atterraggio morbido. Se guardiamo ai casi passati di  Gran parte dell’esuberanza dei mercati finanziari è riconducibile alle aspettative di un significativo
Gran parte dell’esuberanza dei mercati finanziari è riconducibile alle aspettative di un significativo  L’inversione della curva dei rendimenti ha causato una contrazione dei prestiti bancari. Ma come mai l’economia è andata bene lo stesso? Grazie al sostegno fiscale, prima direttamente alle famiglie sotto forma di helicopter money e poi sotto forma di incentivi alle imprese e alla spesa infrastrutturale, che ha più che compensato il vuoto lasciato dalle banche. Quanto può durare? Il governo degli Stati Uniti sta attualmente gestendo uno dei deficit più ampi del secondo dopoguerra, senza essere in recessione. In teoria, non ci sono limiti alla crescita del deficit e il 2024 è un anno di elezioni, quindi dubitiamo che l’amministrazione Biden voglia ridurre la spesa. Ma ci risulta difficile credere che possa crescere ancora molto. Con l’eccesso di risparmio delle famiglie che tende a zero, il rischio che l’economia inizi a singhiozzare non è irrilevante.
L’inversione della curva dei rendimenti ha causato una contrazione dei prestiti bancari. Ma come mai l’economia è andata bene lo stesso? Grazie al sostegno fiscale, prima direttamente alle famiglie sotto forma di helicopter money e poi sotto forma di incentivi alle imprese e alla spesa infrastrutturale, che ha più che compensato il vuoto lasciato dalle banche. Quanto può durare? Il governo degli Stati Uniti sta attualmente gestendo uno dei deficit più ampi del secondo dopoguerra, senza essere in recessione. In teoria, non ci sono limiti alla crescita del deficit e il 2024 è un anno di elezioni, quindi dubitiamo che l’amministrazione Biden voglia ridurre la spesa. Ma ci risulta difficile credere che possa crescere ancora molto. Con l’eccesso di risparmio delle famiglie che tende a zero, il rischio che l’economia inizi a singhiozzare non è irrilevante. Dopo gli Stati Uniti, le economie dell’Europa e della
Dopo gli Stati Uniti, le economie dell’Europa e della  L’attività economica cinese è migliorata moderatamente negli ultimi anni, sostenuta da stimoli bassi ma incessanti, volti a stabilizzare un’economia malconcia, ma consapevoli che una significativa ri-accelerazione dell’attività potrebbe essere dannosa per una nazione indebitata. Il rallentamento della domanda esterna di beni cinesi, unito alla ripresa delle catene di approvvigionamento, ha portato l’
L’attività economica cinese è migliorata moderatamente negli ultimi anni, sostenuta da stimoli bassi ma incessanti, volti a stabilizzare un’economia malconcia, ma consapevoli che una significativa ri-accelerazione dell’attività potrebbe essere dannosa per una nazione indebitata. Il rallentamento della domanda esterna di beni cinesi, unito alla ripresa delle catene di approvvigionamento, ha portato l’
 In base alle analisi sul ciclo del credito e del debito degli ultimi 15 anni, è particolarmente difficile che il sistema possa avere un soft landing, ed è ancora più difficile che i tassi possano rimanere alti per lungo tempo. L’economia mondiale ha costruito la crescita degli ultimi 10/15 anni sull’uso esasperato della leva finanziaria, sia nel settore pubblico ma in particolare in quello privato. Il sistema non è in grado di reggere un costo del debito ai tassi attuali, dato che i FED Funds al 5,25% non sono il tasso di riferimento del costo del debito del sistema, ma sono semplicemente il tasso minimo di riferimento da cui si calcolano gli spread sul credito. Quindi, per fare un esempio, le carte di credito e il credito al consumo nel suo complesso applicano generalmente un tasso d’interesse basato sui FED Funds, a cui si aggiunge lo spread che deve essere applicato al rating del debitore.
In base alle analisi sul ciclo del credito e del debito degli ultimi 15 anni, è particolarmente difficile che il sistema possa avere un soft landing, ed è ancora più difficile che i tassi possano rimanere alti per lungo tempo. L’economia mondiale ha costruito la crescita degli ultimi 10/15 anni sull’uso esasperato della leva finanziaria, sia nel settore pubblico ma in particolare in quello privato. Il sistema non è in grado di reggere un costo del debito ai tassi attuali, dato che i FED Funds al 5,25% non sono il tasso di riferimento del costo del debito del sistema, ma sono semplicemente il tasso minimo di riferimento da cui si calcolano gli spread sul credito. Quindi, per fare un esempio, le carte di credito e il credito al consumo nel suo complesso applicano generalmente un tasso d’interesse basato sui FED Funds, a cui si aggiunge lo spread che deve essere applicato al rating del debitore. Attualmente, il tasso minimo per un cliente Prime sulle carte di credito è il 22%, per i clienti Subprime è al 27%. Il credito che passa dallo Shadow Banking System e che eroga oltre il 60% del credito all’economia non presta certamente denaro ai tassi del 5,25%. Private Credit, Mutual Funds, Fondi Pensione, Hedge Funds specializzati nel settore dei Loans, prestano a tassi con spreads molto elevati. I Leverage Loans pagano il 15%-20% di tasso d’interesse e il Private Credit eroga in media al 12%-15%. I prestiti auto rendono dall’8% al 15% a seconda del rating del debitore. Il Real Estate ha un costo di finanziamento del 7,5% circa per un cliente Prime, mentre il Commercial Real Estate si rifinanzia al 8%-13% a seconda del rischio del debitore. Poiché l’economia americana, durante l’era del QE, ha emesso in massa credito speculativo ad alto rendimento, il costo del debito di sistema non è quello che passa attraverso il canale bancario, bensì quello che passa attraverso lo Shadow Banking, che ormai costituisce il vero canale del credito all’economia.
Attualmente, il tasso minimo per un cliente Prime sulle carte di credito è il 22%, per i clienti Subprime è al 27%. Il credito che passa dallo Shadow Banking System e che eroga oltre il 60% del credito all’economia non presta certamente denaro ai tassi del 5,25%. Private Credit, Mutual Funds, Fondi Pensione, Hedge Funds specializzati nel settore dei Loans, prestano a tassi con spreads molto elevati. I Leverage Loans pagano il 15%-20% di tasso d’interesse e il Private Credit eroga in media al 12%-15%. I prestiti auto rendono dall’8% al 15% a seconda del rating del debitore. Il Real Estate ha un costo di finanziamento del 7,5% circa per un cliente Prime, mentre il Commercial Real Estate si rifinanzia al 8%-13% a seconda del rischio del debitore. Poiché l’economia americana, durante l’era del QE, ha emesso in massa credito speculativo ad alto rendimento, il costo del debito di sistema non è quello che passa attraverso il canale bancario, bensì quello che passa attraverso lo Shadow Banking, che ormai costituisce il vero canale del credito all’economia. L’insostenibilità degli aiuti USA.
L’insostenibilità degli aiuti USA. Debt Ceiling gira attorno alla costante esigenza di supportare un sistema in crisi che non riesce a ripartire veramente. Anche le statistiche relative alla crescita dei redditi reali negli Stati Uniti, che evidenziano un netto miglioramento del potere di acquisto dei privati cittadini, sono in realtà inficiate dagli aiuti governativi erogati in questi anni, che ovviamente non sono sostenibili. Siamo giunti alla paradossale situazione in cui lo stato eroga sussidi per sostenere consumi e credito al consumo, per evitare i default sul credito e per evitare la recessione.
Debt Ceiling gira attorno alla costante esigenza di supportare un sistema in crisi che non riesce a ripartire veramente. Anche le statistiche relative alla crescita dei redditi reali negli Stati Uniti, che evidenziano un netto miglioramento del potere di acquisto dei privati cittadini, sono in realtà inficiate dagli aiuti governativi erogati in questi anni, che ovviamente non sono sostenibili. Siamo giunti alla paradossale situazione in cui lo stato eroga sussidi per sostenere consumi e credito al consumo, per evitare i default sul credito e per evitare la recessione. sistema non è compatibile con un soft landing. A questo punto ci troviamo nella critica situazione in cui: 1) il costo di finanziamento all’economia erogato dallo Shadow Banking System è estremamente già restrittivo. 2) le politiche fiscali di supporto non sono sostenibili. 3) i tassi di default stanno iniziando a salire in modo inesorabile. 4) le banche hanno fermato l’erogazione del credito. Quindi il “soft landing“, come ho avuto già modo di evidenziare, può diventare un “hard landing” a causa dell’avvio del deleverage di sistema, oppure, se vuoi frenare il deleverage, si trasforma in un “long landing“.
sistema non è compatibile con un soft landing. A questo punto ci troviamo nella critica situazione in cui: 1) il costo di finanziamento all’economia erogato dallo Shadow Banking System è estremamente già restrittivo. 2) le politiche fiscali di supporto non sono sostenibili. 3) i tassi di default stanno iniziando a salire in modo inesorabile. 4) le banche hanno fermato l’erogazione del credito. Quindi il “soft landing“, come ho avuto già modo di evidenziare, può diventare un “hard landing” a causa dell’avvio del deleverage di sistema, oppure, se vuoi frenare il deleverage, si trasforma in un “long landing“. Per quanto riguarda la narrativa sul tema “higher for longer“, anche qui si parla senza sapere come siamo messi veramente. Il sistema non è in grado di reggere l’attuale livello dei tassi per molto tempo. I vari segmenti del mercato del credito che ho elencato in precedenza hanno già politiche monetarie molto restrittive, quindi il cedimento del ciclo è imminente. Non credo in nessun modo che i tassi possano reggere gli attuali livelli se il contesto nel quale ci stiamo addentrando è quello di una recessione o una lunga fase di deleverage, che produce una stagnazione economica.
Per quanto riguarda la narrativa sul tema “higher for longer“, anche qui si parla senza sapere come siamo messi veramente. Il sistema non è in grado di reggere l’attuale livello dei tassi per molto tempo. I vari segmenti del mercato del credito che ho elencato in precedenza hanno già politiche monetarie molto restrittive, quindi il cedimento del ciclo è imminente. Non credo in nessun modo che i tassi possano reggere gli attuali livelli se il contesto nel quale ci stiamo addentrando è quello di una recessione o una lunga fase di deleverage, che produce una stagnazione economica. Il debito contratto, oltre che avere un costo rappresentato dei tassi d’interesse applicati, ha anche un costo complessivo determinato da quanto PIL devi dedicare al servizio del debito totale di sistema. Se hai un debito pubblico e privato pari al 370% del Pil (Stati Uniti), e il suo costo annuo è pari mediamente al 7%, il costo annuo di quel debito assorbe il 25% del PIL. Tutte le volte che il costo per sostenere il debito raggiunge una percentuale pari o superiore al 20% del PIL l’economia inizia a cedere in modo evidente. Questo è accaduto nel 2001, quando il costo per sostenere il debito contratto dal sistema era pari al 21% del PIL, nel 2007, quando aveva raggiunto il 23% del PIL e ora al 22%. Nei due i casi precedenti i tassi hanno dovuto scendere per evitare un avvitamento deflattivo, dato che nelle ultime due importanti crisi (2001 e 2008), il trigger è partito dal livello di indebitamento del sistema e dal credito speculativo concentrato sul settore driver della crescita, nel 2001 la tecnologia e nel 2008 Real Estate.
Il debito contratto, oltre che avere un costo rappresentato dei tassi d’interesse applicati, ha anche un costo complessivo determinato da quanto PIL devi dedicare al servizio del debito totale di sistema. Se hai un debito pubblico e privato pari al 370% del Pil (Stati Uniti), e il suo costo annuo è pari mediamente al 7%, il costo annuo di quel debito assorbe il 25% del PIL. Tutte le volte che il costo per sostenere il debito raggiunge una percentuale pari o superiore al 20% del PIL l’economia inizia a cedere in modo evidente. Questo è accaduto nel 2001, quando il costo per sostenere il debito contratto dal sistema era pari al 21% del PIL, nel 2007, quando aveva raggiunto il 23% del PIL e ora al 22%. Nei due i casi precedenti i tassi hanno dovuto scendere per evitare un avvitamento deflattivo, dato che nelle ultime due importanti crisi (2001 e 2008), il trigger è partito dal livello di indebitamento del sistema e dal credito speculativo concentrato sul settore driver della crescita, nel 2001 la tecnologia e nel 2008 Real Estate. Il problema del lungo e recente ciclo del credito innescato dal QE delle banche Centrali è che il credito speculativo si è sparso in vari settori dell’economia e non è più concentrato in un unico driver di crescita. Il Commercial Real Estate ha 3,3 Trilioni di debito outstanding di cui circa il 30% è speculativo, il Venture Capital si sostiene con 1,5 Tr di Leverage Loans (tutto debito speculativo), che sostengono a loro volta le posizioni dei Fondi di Private Equity, che valgono complessivamente 9 Tr di USD (40% del PIL USA), e che operano decisamente a leva, sia attraverso i Leverage Loans sia attraverso il credito speculativo dello Shadow Banking e delle banche. Il credito al consumo, circa 4,5 trilioni di USD, è tipicamente al 25% Subprime.
Il problema del lungo e recente ciclo del credito innescato dal QE delle banche Centrali è che il credito speculativo si è sparso in vari settori dell’economia e non è più concentrato in un unico driver di crescita. Il Commercial Real Estate ha 3,3 Trilioni di debito outstanding di cui circa il 30% è speculativo, il Venture Capital si sostiene con 1,5 Tr di Leverage Loans (tutto debito speculativo), che sostengono a loro volta le posizioni dei Fondi di Private Equity, che valgono complessivamente 9 Tr di USD (40% del PIL USA), e che operano decisamente a leva, sia attraverso i Leverage Loans sia attraverso il credito speculativo dello Shadow Banking e delle banche. Il credito al consumo, circa 4,5 trilioni di USD, è tipicamente al 25% Subprime. Un altro problema che caratterizza i cicli del debito e del debito speculativo è che la percentuale di debito a rischio in circolazione, e il suo costo, sale in concomitanza con il cedimento del ciclo dell’economia e il risk off di sistema. Quindi, mentre abbiamo le statistiche ad oggi che ci dicono quanto debito speculativo circola attualmente nel sistema, non sappiamo di quanto aumenta tale importo se lo scenario di recessione o stagnazione si concretizza. Nel momento in cui parte una crisi il costo del debito tende inizialmente a salire, dato che chi presta denaro tende ad essere più prudente e
Un altro problema che caratterizza i cicli del debito e del debito speculativo è che la percentuale di debito a rischio in circolazione, e il suo costo, sale in concomitanza con il cedimento del ciclo dell’economia e il risk off di sistema. Quindi, mentre abbiamo le statistiche ad oggi che ci dicono quanto debito speculativo circola attualmente nel sistema, non sappiamo di quanto aumenta tale importo se lo scenario di recessione o stagnazione si concretizza. Nel momento in cui parte una crisi il costo del debito tende inizialmente a salire, dato che chi presta denaro tende ad essere più prudente e  chiede una remunerazione più alta in un contesto di rischio. La politica monetaria esercitata dallo Shadow Banking diventa dunque restrittiva e il costo di credito del sistema in relazione al PIL tende ancora a salire nella fase iniziale della crisi. Si verifica così un overshooting restrittivo che sfugge al controllo della Banca Centrale e che accentua la fase iniziale della crisi. Un’altra caratteristica del ciclo del credito è che è pro-ciclico, aumenta quando l’economia cresce e si contrae quando l’economia entra in crisi, il meccanismo è determinato dalla propensione al rischio del lender. Quindi, mentre i tassi d’interesse incidono sulla domanda di credito, la propensione al rischio dello Shadow Banking e del sistema bancario incidono invece sull’offerta.
chiede una remunerazione più alta in un contesto di rischio. La politica monetaria esercitata dallo Shadow Banking diventa dunque restrittiva e il costo di credito del sistema in relazione al PIL tende ancora a salire nella fase iniziale della crisi. Si verifica così un overshooting restrittivo che sfugge al controllo della Banca Centrale e che accentua la fase iniziale della crisi. Un’altra caratteristica del ciclo del credito è che è pro-ciclico, aumenta quando l’economia cresce e si contrae quando l’economia entra in crisi, il meccanismo è determinato dalla propensione al rischio del lender. Quindi, mentre i tassi d’interesse incidono sulla domanda di credito, la propensione al rischio dello Shadow Banking e del sistema bancario incidono invece sull’offerta.  Le teorie del “soft landing” e del “higher for longer” si basano sul nulla, dato che nessuno è in grado di valutare come si modifica la propensione al rischio di milioni di operatori in una fase di crisi. Mentre negli ultimi due eventi di crisi (2001 e 2008) i salvataggi di sistema sono stati più facili perché la crisi ha colpito uno specifico segmento del credito (credito speculativo nel settore tecnologico e nel real estate), oggi la situazione è particolarmente complicata perché il credito potenzialmente a rischio è sparso in modo trasversale nell’economia e diffuso in più settori. I tassi a zero per oltre 14 anni, perseguiti con l’intento di sostenere il sistema, hanno gettato le basi per la sua instabilità di lungo termine.
Le teorie del “soft landing” e del “higher for longer” si basano sul nulla, dato che nessuno è in grado di valutare come si modifica la propensione al rischio di milioni di operatori in una fase di crisi. Mentre negli ultimi due eventi di crisi (2001 e 2008) i salvataggi di sistema sono stati più facili perché la crisi ha colpito uno specifico segmento del credito (credito speculativo nel settore tecnologico e nel real estate), oggi la situazione è particolarmente complicata perché il credito potenzialmente a rischio è sparso in modo trasversale nell’economia e diffuso in più settori. I tassi a zero per oltre 14 anni, perseguiti con l’intento di sostenere il sistema, hanno gettato le basi per la sua instabilità di lungo termine.
 dell’inflazione complessiva, anche se l’inflazione di fondo resta elevata, soprattutto nel settore dei servizi. Non va pertanto sottovalutata la determinazione delle banche centrali a riportare l’inflazione al livello obiettivo del 2%. Un ritardo nel raggiungimento di tale target o addirittura un’accelerazione dell’indice dei prezzi costringerebbe le banche centrali a schiacciare nuovamente il pedale del freno, inasprendo nuovamente la politica monetaria e rischiando di innescare una recessione. Attualmente, però, non ci attendiamo alcun intervento sui tassi, o al massimo un solo rialzo, da parte delle due principali banche centrali.
dell’inflazione complessiva, anche se l’inflazione di fondo resta elevata, soprattutto nel settore dei servizi. Non va pertanto sottovalutata la determinazione delle banche centrali a riportare l’inflazione al livello obiettivo del 2%. Un ritardo nel raggiungimento di tale target o addirittura un’accelerazione dell’indice dei prezzi costringerebbe le banche centrali a schiacciare nuovamente il pedale del freno, inasprendo nuovamente la politica monetaria e rischiando di innescare una recessione. Attualmente, però, non ci attendiamo alcun intervento sui tassi, o al massimo un solo rialzo, da parte delle due principali banche centrali.
 Eurozona – I dati del Pil del secondo trimestre indicano che l’economia della regione ha superato la recessione tecnica in cui era scivolata nel quarto trimestre del 2022. L’economia dell’area euro continua tuttavia a ristagnare, con Germania e Italia che si distinguono per la crescita molto debole. Ciò che risulta particolarmente preoccupante è la contrazione in atto nel terziario, che nel primo semestre di quest’anno aveva trainato la ripresa. Ad agosto il Purchasing Managers’ Index ha subito una drastica flessione, precipitando in territorio negativo. La fiducia dei consumatori è risalita
Eurozona – I dati del Pil del secondo trimestre indicano che l’economia della regione ha superato la recessione tecnica in cui era scivolata nel quarto trimestre del 2022. L’economia dell’area euro continua tuttavia a ristagnare, con Germania e Italia che si distinguono per la crescita molto debole. Ciò che risulta particolarmente preoccupante è la contrazione in atto nel terziario, che nel primo semestre di quest’anno aveva trainato la ripresa. Ad agosto il Purchasing Managers’ Index ha subito una drastica flessione, precipitando in territorio negativo. La fiducia dei consumatori è risalita  dai precedenti bassi livelli, favorita dalla solidità del mercato del lavoro, mentre i dati “hard” hanno deluso su quasi tutta la linea. Il settore manifatturiero ha risentito della debole domanda estera, quello immobiliare resta sotto pressione e, malgrado il miglioramento dell’inflazione complessiva, l’inflazione di fondo persiste a quota 5,5%. I tassi reali sono pertanto scesi in territorio negativo e la Bce resta quindi alle prese con il dilemma di dover operare una stretta malgrado il rallentamento economico. Prevediamo tuttavia che la Bce effettuerà al massimo ancora un solo rialzo, per poi prendersi una pausa in attesa della pubblicazione dei prossimi dati macro.
dai precedenti bassi livelli, favorita dalla solidità del mercato del lavoro, mentre i dati “hard” hanno deluso su quasi tutta la linea. Il settore manifatturiero ha risentito della debole domanda estera, quello immobiliare resta sotto pressione e, malgrado il miglioramento dell’inflazione complessiva, l’inflazione di fondo persiste a quota 5,5%. I tassi reali sono pertanto scesi in territorio negativo e la Bce resta quindi alle prese con il dilemma di dover operare una stretta malgrado il rallentamento economico. Prevediamo tuttavia che la Bce effettuerà al massimo ancora un solo rialzo, per poi prendersi una pausa in attesa della pubblicazione dei prossimi dati macro. Cina – Quest’anno l’economia cinese avrebbe dovuto imprimere slancio alla crescita globale, invece in agosto l’economia ha subito un ulteriore rallentamento, malgrado la ferma intenzione delle autorità di sostenere la congiuntura. Il crollo del mercato immobiliare ha nuovamente causato effetti negativi, innescando una crisi di liquidità nel sistema bancario ombra e ulteriori insolvenze tra le società immobiliari. Per contenere la crisi, Il Politburo ha ripetutamente sottolineato la necessità di misure politiche mirate volte a ripristinare la fiducia del settore
Cina – Quest’anno l’economia cinese avrebbe dovuto imprimere slancio alla crescita globale, invece in agosto l’economia ha subito un ulteriore rallentamento, malgrado la ferma intenzione delle autorità di sostenere la congiuntura. Il crollo del mercato immobiliare ha nuovamente causato effetti negativi, innescando una crisi di liquidità nel sistema bancario ombra e ulteriori insolvenze tra le società immobiliari. Per contenere la crisi, Il Politburo ha ripetutamente sottolineato la necessità di misure politiche mirate volte a ripristinare la fiducia del settore 
 Siamo ora giunti al momento fatidico in cui è necessario scegliere tra un deleverage lento ma lungo oppure profondo ma rapido. A mio parere, a causa dello stock di debito accumulato nel sistema a tassi molto bassi, non siamo in grado di permetterci un deleverage rapido come nel 2008. Il sistema non reggerebbe. È quindi molto probabile che ci sarà il tentativo di intraprendere un deleverage lento e controllato. Tutto il debito contratto a tassi bassi dovrà essere, prima o poi, rinnovato a tassi più alti. Molti operatori economici non reggeranno il rollover ai tassi attuali e le insolvenze rimarranno un fenomeno strutturale dell’economia post QE. Il lento processo di assorbimento delle insolvenze sul debito, non sopportabile a tassi diversi da zero, configura lo scenario di Balance Sheet Recession in cui ci stiamo addentrando, che con un eufemismo chiamiamo soft landing.
Siamo ora giunti al momento fatidico in cui è necessario scegliere tra un deleverage lento ma lungo oppure profondo ma rapido. A mio parere, a causa dello stock di debito accumulato nel sistema a tassi molto bassi, non siamo in grado di permetterci un deleverage rapido come nel 2008. Il sistema non reggerebbe. È quindi molto probabile che ci sarà il tentativo di intraprendere un deleverage lento e controllato. Tutto il debito contratto a tassi bassi dovrà essere, prima o poi, rinnovato a tassi più alti. Molti operatori economici non reggeranno il rollover ai tassi attuali e le insolvenze rimarranno un fenomeno strutturale dell’economia post QE. Il lento processo di assorbimento delle insolvenze sul debito, non sopportabile a tassi diversi da zero, configura lo scenario di Balance Sheet Recession in cui ci stiamo addentrando, che con un eufemismo chiamiamo soft landing.
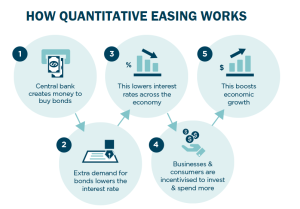 Ho la sensazione che l’intera economia mondiale (dagli Stati Uniti a UK, Australia, Canada e Cina), abbia accumulato debito per acquistare asset a redditività compatibile con tassi d’interesse molto bassi. Il problema è che, poiché il QE è durato 14 anni, la dimensione di tali posizioni è sconosciuta ma certamente colossale. Il motivo per il quale il “soft landing” potrebbe essere “giapponese” è quindi collegato a quello che abbiamo fatto in 14 anni di QE. I titoli di stato che procurano i problemi ai bilanci bancari sono un altro eclatante esempio. È chiaro che lo stesso principio va esteso agli investimenti reali nel suo complesso e non possiamo essere così ingenui da pensare che anche altri segmenti dell’economia reale non siano esposti alla stessa situazione (bassa redditività e debito più caro).
Ho la sensazione che l’intera economia mondiale (dagli Stati Uniti a UK, Australia, Canada e Cina), abbia accumulato debito per acquistare asset a redditività compatibile con tassi d’interesse molto bassi. Il problema è che, poiché il QE è durato 14 anni, la dimensione di tali posizioni è sconosciuta ma certamente colossale. Il motivo per il quale il “soft landing” potrebbe essere “giapponese” è quindi collegato a quello che abbiamo fatto in 14 anni di QE. I titoli di stato che procurano i problemi ai bilanci bancari sono un altro eclatante esempio. È chiaro che lo stesso principio va esteso agli investimenti reali nel suo complesso e non possiamo essere così ingenui da pensare che anche altri segmenti dell’economia reale non siano esposti alla stessa situazione (bassa redditività e debito più caro). Quando sopprimi il costo del debito, tutto il break even di sistema si abbassa, quando lo alzi accade il contrario. All’inizio, le aziende cercano di contenere il problema alzando i prezzi e innescano l’inflazione, ma poi i redditi reali si contraggono, i consumi cedono e l’economia si ferma. Nel frattempo i principali paesi che sono al centro dell’export globale (Cina, Giappone e Germania) continuano a evidenziare un cedimento della domanda globale. Il Giappone è stato il principale “svalutatore” competitivo negli ultimi 12/18 mesi ma il suo export globale non cresce, anzi scende. L’economia cinese è in grave difficoltà a causa del deleverage nel settore immobiliare, per un maggiore controllo delle allegre politiche fiscali dei governi locali e per la deglobalizzazione innescata dagli Stati Uniti. Il China Reopening è stato un tema “venduto” agli investitori per sostenere l’idea della ripresa globale, ma in realtà la Cina non vuole più fare la locomotiva dell’economia mondiale sul debito. Anzi, la priorità del governo centrale è quella di avviare un deleverage controllato del sistema (tentativo di soft landing anche qui).
Quando sopprimi il costo del debito, tutto il break even di sistema si abbassa, quando lo alzi accade il contrario. All’inizio, le aziende cercano di contenere il problema alzando i prezzi e innescano l’inflazione, ma poi i redditi reali si contraggono, i consumi cedono e l’economia si ferma. Nel frattempo i principali paesi che sono al centro dell’export globale (Cina, Giappone e Germania) continuano a evidenziare un cedimento della domanda globale. Il Giappone è stato il principale “svalutatore” competitivo negli ultimi 12/18 mesi ma il suo export globale non cresce, anzi scende. L’economia cinese è in grave difficoltà a causa del deleverage nel settore immobiliare, per un maggiore controllo delle allegre politiche fiscali dei governi locali e per la deglobalizzazione innescata dagli Stati Uniti. Il China Reopening è stato un tema “venduto” agli investitori per sostenere l’idea della ripresa globale, ma in realtà la Cina non vuole più fare la locomotiva dell’economia mondiale sul debito. Anzi, la priorità del governo centrale è quella di avviare un deleverage controllato del sistema (tentativo di soft landing anche qui).
 Gli student loans sono un esempio eclatante. La moratoria sui pagamenti è stata ulteriormente prorogata fino a ottobre (sarebbe scaduta il 30 giugno), consentendo a 26 milioni di famiglie americane di non pagare (ormai dal 2020) interessi e debito su 1,1 trilioni di USD, importo pari a circa il 4% del PIL. Il credito al consumo nel suo complesso è pari ora a oltre 5 trilioni di USD, oltre il 20% del PIL americano (contro il 10% del periodo pre-2008) e ha costituito, assieme all’espansione del debito pubblico, il motore della crescita. Ma nonostante tutti questi sussidi pubblici, l’economia rallenta, i consumi hanno iniziato a cedere e i tassi di default sul credito hanno iniziato a salire comunque.
Gli student loans sono un esempio eclatante. La moratoria sui pagamenti è stata ulteriormente prorogata fino a ottobre (sarebbe scaduta il 30 giugno), consentendo a 26 milioni di famiglie americane di non pagare (ormai dal 2020) interessi e debito su 1,1 trilioni di USD, importo pari a circa il 4% del PIL. Il credito al consumo nel suo complesso è pari ora a oltre 5 trilioni di USD, oltre il 20% del PIL americano (contro il 10% del periodo pre-2008) e ha costituito, assieme all’espansione del debito pubblico, il motore della crescita. Ma nonostante tutti questi sussidi pubblici, l’economia rallenta, i consumi hanno iniziato a cedere e i tassi di default sul credito hanno iniziato a salire comunque. Il modello capital-socialista americano, dove le aziende private e le società di credito al consumo fanno profitti sovvenzionati dai sussidi pubblici erogati a consumatori oberati dal debito, inizia a cedere in modo evidente. In realtà stava già cedendo nel 2019, ma il Covid è stata una grande opportunità per giustificare interventi straordinari di salvataggio. Gli artifici contabili per non fare uscire un PIL negativo e sbandierare un mercato del lavoro solido contrastano con i principali indicatori di consumer confidence, leading indicators (principali indicatori macroeconomici, ndr), fiducia delle imprese e cash flow in contrazione per le società quotate (inclusi i famosi “FAANG“, acronimo che indica le aziende Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google che operano in posizioni di monopolio e sostengono l’indice di borsa con i buy back). Le aziende multinazionali trattengono i profitti fatti all’estero nei paradisi fiscali, non pagano le tasse al governo americano e utilizzano questi profitti “tax free” per fare buy back direttamente dai paradisi fiscali per sostenere la borsa.
Il modello capital-socialista americano, dove le aziende private e le società di credito al consumo fanno profitti sovvenzionati dai sussidi pubblici erogati a consumatori oberati dal debito, inizia a cedere in modo evidente. In realtà stava già cedendo nel 2019, ma il Covid è stata una grande opportunità per giustificare interventi straordinari di salvataggio. Gli artifici contabili per non fare uscire un PIL negativo e sbandierare un mercato del lavoro solido contrastano con i principali indicatori di consumer confidence, leading indicators (principali indicatori macroeconomici, ndr), fiducia delle imprese e cash flow in contrazione per le società quotate (inclusi i famosi “FAANG“, acronimo che indica le aziende Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google che operano in posizioni di monopolio e sostengono l’indice di borsa con i buy back). Le aziende multinazionali trattengono i profitti fatti all’estero nei paradisi fiscali, non pagano le tasse al governo americano e utilizzano questi profitti “tax free” per fare buy back direttamente dai paradisi fiscali per sostenere la borsa.
 L’economia americana appare ora disperatamente focalizzata a cercare di sostenere un modello di sviluppo basato su un debito pubblico e privato insostenibile e un mercato finanziario che non può permettersi nessun cedimento, dato che una cosa sostiene l’altra e viceversa (il debito sostiene la crescita e il mercato finanziario sostiene il debito). Ma questo meccanismo può reggere solo se la ricchezza prodotta si distribuisce in modo diffuso nel sistema e alimenta una crescita generale dei redditi che sostengono un debito in costante accumulazione. Appare evidente che attualmente non è così. (Nel grafico: La linea verde indica l’andamento della concentrazione di ricchezza detenuto dal top 0,1% della popolazione USA dal 1980. Fonte Federal Reserve).
L’economia americana appare ora disperatamente focalizzata a cercare di sostenere un modello di sviluppo basato su un debito pubblico e privato insostenibile e un mercato finanziario che non può permettersi nessun cedimento, dato che una cosa sostiene l’altra e viceversa (il debito sostiene la crescita e il mercato finanziario sostiene il debito). Ma questo meccanismo può reggere solo se la ricchezza prodotta si distribuisce in modo diffuso nel sistema e alimenta una crescita generale dei redditi che sostengono un debito in costante accumulazione. Appare evidente che attualmente non è così. (Nel grafico: La linea verde indica l’andamento della concentrazione di ricchezza detenuto dal top 0,1% della popolazione USA dal 1980. Fonte Federal Reserve). Cercare però di modificare ora questo sistema appare alquanto difficile, dato che, in un contesto di alta inflazione, i redditi reali devono scendere e non salire per frenare la domanda, ma il debito (pubblico o privato) deve continuare a salire comunque, perchè se il debito si contrae il ciclo economico va a picco. I tassi d’interesse dovrebbero rimanere bassi per sostenere il debito che sostiene il ciclo dei consumi, ma ormai siamo usciti da questo scenario da oltre 12 mesi e non sappiamo ancora quale sarà il notevole impatto effettivo delle politiche monetarie sull’economia. L’inflazione ha già scardinato il sistema e l’indice di borsa rimane l’ultimo baluardo di difesa sulla psicologia di massa prima della crisi, ma per reggere
Cercare però di modificare ora questo sistema appare alquanto difficile, dato che, in un contesto di alta inflazione, i redditi reali devono scendere e non salire per frenare la domanda, ma il debito (pubblico o privato) deve continuare a salire comunque, perchè se il debito si contrae il ciclo economico va a picco. I tassi d’interesse dovrebbero rimanere bassi per sostenere il debito che sostiene il ciclo dei consumi, ma ormai siamo usciti da questo scenario da oltre 12 mesi e non sappiamo ancora quale sarà il notevole impatto effettivo delle politiche monetarie sull’economia. L’inflazione ha già scardinato il sistema e l’indice di borsa rimane l’ultimo baluardo di difesa sulla psicologia di massa prima della crisi, ma per reggere  richiede un esasperato scostamento dai fondamentali che a sua volta spiazza gli investitori a favore degli speculatori. Per sostenere questo mercato, le poche aziende che possono permetterselo devono continuare inesorabilmente a fare buy back, sottraendo risorse agli investimenti reali e accentuando la stagnazione dell’economia, che richiede poi costante debito pubblico per sostenersi. Nel frattempo, la Germania e l’Europa sono esposti alle decisioni di geopolitica degli Stati Uniti, che hanno portato alla eliminazione del fornitore di energia a basso costo (Russia), e ora puntano a ridimensionare l’interscambio commerciale con la Cina, principale partner commerciale dell’Europa e del Giappone.
richiede un esasperato scostamento dai fondamentali che a sua volta spiazza gli investitori a favore degli speculatori. Per sostenere questo mercato, le poche aziende che possono permetterselo devono continuare inesorabilmente a fare buy back, sottraendo risorse agli investimenti reali e accentuando la stagnazione dell’economia, che richiede poi costante debito pubblico per sostenersi. Nel frattempo, la Germania e l’Europa sono esposti alle decisioni di geopolitica degli Stati Uniti, che hanno portato alla eliminazione del fornitore di energia a basso costo (Russia), e ora puntano a ridimensionare l’interscambio commerciale con la Cina, principale partner commerciale dell’Europa e del Giappone.
 Nella seconda metà del 2022 l’economia Usa ha continuato a esibire vigore e i recenti dati indicano un solido andamento congiunturale all’inizio del 2023. L’effetto ritardato dell’inasprimento monetario e di ulteriori giri di vite da parte della Fed potrebbero tuttavia causare il rallentamento della crescita. I settori sensibili ai tassi (immobili residenziali) hanno evidenziato una contrazione per diversi mesi. La produzione industriale, gli investimenti aziendali e gli indicatori regionali del settore manifatturiero tendono al ribasso e fanno temere che la congiuntura statunitense potrebbe presto subire un raffreddamento. Al momento, il mercato del lavoro ha raggiunto la piena occupazione, ma la domanda di manodopera va indebolendosi in molti settori, al pari degli aumenti salariali. I redditi, i consumi privati e il commercio al dettaglio si sono ripresi dopo la debolezza di fine 2022, ma prima o poi le pressioni dovute al calo dei redditi reali saranno avvertite dai consumatori.
Nella seconda metà del 2022 l’economia Usa ha continuato a esibire vigore e i recenti dati indicano un solido andamento congiunturale all’inizio del 2023. L’effetto ritardato dell’inasprimento monetario e di ulteriori giri di vite da parte della Fed potrebbero tuttavia causare il rallentamento della crescita. I settori sensibili ai tassi (immobili residenziali) hanno evidenziato una contrazione per diversi mesi. La produzione industriale, gli investimenti aziendali e gli indicatori regionali del settore manifatturiero tendono al ribasso e fanno temere che la congiuntura statunitense potrebbe presto subire un raffreddamento. Al momento, il mercato del lavoro ha raggiunto la piena occupazione, ma la domanda di manodopera va indebolendosi in molti settori, al pari degli aumenti salariali. I redditi, i consumi privati e il commercio al dettaglio si sono ripresi dopo la debolezza di fine 2022, ma prima o poi le pressioni dovute al calo dei redditi reali saranno avvertite dai consumatori. Dopo il ciclo di inasprimento più aggressivo degli ultimi 40 anni, la Fed ha in parte raggiunto il proprio obiettivo di riduzione della domanda, ma non ha ancora terminato il suo compito e i rischi di recessione sono decisamente aumentati. Per evitare un grave crollo congiunturale, la Fed ha gradualmente ridotto il ritmo dei rialzi, ma continuerà probabilmente ad aumentare il costo del denaro fino all’estate in attesa di osservare le ripercussioni complessive della sua politica. Un soft landing resta possibile ma sarà difficile orchestrarlo, e la strada in tale direzione è irta di ostacoli. L’inflazione nel terziario
Dopo il ciclo di inasprimento più aggressivo degli ultimi 40 anni, la Fed ha in parte raggiunto il proprio obiettivo di riduzione della domanda, ma non ha ancora terminato il suo compito e i rischi di recessione sono decisamente aumentati. Per evitare un grave crollo congiunturale, la Fed ha gradualmente ridotto il ritmo dei rialzi, ma continuerà probabilmente ad aumentare il costo del denaro fino all’estate in attesa di osservare le ripercussioni complessive della sua politica. Un soft landing resta possibile ma sarà difficile orchestrarlo, e la strada in tale direzione è irta di ostacoli. L’inflazione nel terziario  Per quanto riguarda l’Eurozona, nel 2022 la sua economia si è mostrata sorprendentemente robusta. Malgrado l’inflazione storicamente elevata, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e il rallentamento congiunturale in Cina, l’area Euro è riuscita a evitare la recessione. La solidità del mercato del lavoro, unita al forte sostegno fiscale e all’atteggiamento cauto della Bce in termini di normalizzazione della politica monetaria, è stata decisiva per evitare un crollo della congiuntura, ma ha contribuito al forte aumento dei prezzi nell’intera regione. Il clima di fiducia, che nell’ultimo anno aveva raggiunto i minimi, è decisamente migliorato.
Per quanto riguarda l’Eurozona, nel 2022 la sua economia si è mostrata sorprendentemente robusta. Malgrado l’inflazione storicamente elevata, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e il rallentamento congiunturale in Cina, l’area Euro è riuscita a evitare la recessione. La solidità del mercato del lavoro, unita al forte sostegno fiscale e all’atteggiamento cauto della Bce in termini di normalizzazione della politica monetaria, è stata decisiva per evitare un crollo della congiuntura, ma ha contribuito al forte aumento dei prezzi nell’intera regione. Il clima di fiducia, che nell’ultimo anno aveva raggiunto i minimi, è decisamente migliorato. I prezzi del gas sono notevolmente scesi, l’approvvigionamento energetico è stato diversificato e i timori di una grave crisi energetica sono spariti. La produzione industriale è debole ma va stabilizzandosi grazie alla riduzione dei problemi lungo le catene di fornitura e alla rimozione delle restrizioni dovute al Covid in Cina. Il mercato del lavoro è robusto e dai sondaggi sulla futura attività economica emergono chiare indicazioni di una crescita economica. “Nonostante la maggiore fiducia nell’economia, le prospettive a medio termine restano impegnative. L’Eurozona deve fare i conti con un rallentamento congiunturale e grandi incertezze, e non si può ancora escludere una lieve recessione nel 2023”, continua Siviero.
I prezzi del gas sono notevolmente scesi, l’approvvigionamento energetico è stato diversificato e i timori di una grave crisi energetica sono spariti. La produzione industriale è debole ma va stabilizzandosi grazie alla riduzione dei problemi lungo le catene di fornitura e alla rimozione delle restrizioni dovute al Covid in Cina. Il mercato del lavoro è robusto e dai sondaggi sulla futura attività economica emergono chiare indicazioni di una crescita economica. “Nonostante la maggiore fiducia nell’economia, le prospettive a medio termine restano impegnative. L’Eurozona deve fare i conti con un rallentamento congiunturale e grandi incertezze, e non si può ancora escludere una lieve recessione nel 2023”, continua Siviero. “Le pressioni sui prezzi” – conclude Siviero – “stanno complessivamente diminuendo, ma l’inflazione sottostante resta troppo elevata e va espandendosi. L’inflazione di fondo rimane ai massimi storici e la domanda interna potrebbe subire una contrazione a causa dell’erosione dei redditi reali. In un contesto di crescita robusta, aumento delle pressioni sui prezzi e sostegno fiscale sostenuto, dalla fine dello scorso anno la Bce ha adottato toni più aggressivi. Avendo avviato tardi i rialzi, la Banca centrale europea deve ora mantenere la rotta perseguendo una politica restrittiva malgrado i potenziali rischi di recessione nella regione e malgrado le recenti tensioni sui mercati finanziari. Il 16 marzo la Bce ha tenuto fede alle sue intenzioni alzando i tassi di riferimento di 50 punti base. Da qui in avanti, l’orientamento aggressivo della Bce potrebbe suscitare domande dovute al peggioramento della congiuntura nella regione e le tensioni politiche potrebbero mettere alla prova la determinazione dei vertici di Francoforte nel perseguire il proprio corso restrittivo”.
“Le pressioni sui prezzi” – conclude Siviero – “stanno complessivamente diminuendo, ma l’inflazione sottostante resta troppo elevata e va espandendosi. L’inflazione di fondo rimane ai massimi storici e la domanda interna potrebbe subire una contrazione a causa dell’erosione dei redditi reali. In un contesto di crescita robusta, aumento delle pressioni sui prezzi e sostegno fiscale sostenuto, dalla fine dello scorso anno la Bce ha adottato toni più aggressivi. Avendo avviato tardi i rialzi, la Banca centrale europea deve ora mantenere la rotta perseguendo una politica restrittiva malgrado i potenziali rischi di recessione nella regione e malgrado le recenti tensioni sui mercati finanziari. Il 16 marzo la Bce ha tenuto fede alle sue intenzioni alzando i tassi di riferimento di 50 punti base. Da qui in avanti, l’orientamento aggressivo della Bce potrebbe suscitare domande dovute al peggioramento della congiuntura nella regione e le tensioni politiche potrebbero mettere alla prova la determinazione dei vertici di Francoforte nel perseguire il proprio corso restrittivo”.








