In politica, il potere gioca su più livelli e ciò che ci viene raccontato è solo lo strato superficiale di qualcosa di più profondo. La verità assoluta sembra quindi irraggiungibile, a meno che non si indaghi sui dettagli.
Di Alessio Cardinale, CEO e direttore editoriale di Patrimoni&Finanza
La verità sui fatti storici e sulle scelte che li hanno determinati non è reperibile dai titoli dei giornali né dai discorsi ufficiali dei protagonisti delle Istituzioni. Essa si annida nei dettagli, nei collegamenti tra gli eventi e nelle dinamiche che pochi hanno la capacità (e la voglia) di approfondire. In più, la ricerca della verità storica è fortemente condizionata da due fattori, e cioè dalla volontà politica di camuffarla e dal tempo: più siamo vicini temporalmente all’accadimento di quei fatti su cui si intende indagare, più è difficile individuare i segreti obiettivi che hanno determinato certe scelte; più ci allontaniamo con il tempo dal momento in cui i fatti si sono verificati, più chiari sono i motivi che hanno spinto i “decisori” di quel tempo a preferire alcune scelte ad altre che erano in teoria più utili e sostenibili.
 La verità assoluta è sempre complessa e irraggiungibile, poichè il potere gioca su più livelli e spesso ciò che appare evidente è solo lo strato superficiale di qualcosa di più profondo. Per avvicinarci alla verità, è fondamentale mettere insieme i pezzi, individuare le connessioni che non vengono mai evidenziate dai media e lavorare sui dettagli più piccoli, che sfuggono all’osservazione perché in apparenza insignificanti. La ricerca della verità è, pertanto, un esercizio di riflessione, di attenzione ai dettagli e soprattutto di logica; logica storica, in particolare, che ci viene in aiuto quando tutte le false ipotesi legate alla narrazione ufficiale cadono una ad una e lasciano aperte, al massimo, solo una o due possibilità, spesso complementari e intrecciate tra loro, ma sicuramente plausibili. Sempre più spesso, infatti, sono i risultati storici susseguenti a certe scelte a suggerire la verità dei “perché” (quelle stesse scelte sono state fatte), lasciando coperta spesso la verità dei “chi” (quelle stesse scelte ha fortemente voluto). Così analizzando i fatti, i dettagli trovano miracolosamente una loro collocazione, come in un puzzle dalle tessere mancanti, e tutto nel tempo diventa più chiaro.
La verità assoluta è sempre complessa e irraggiungibile, poichè il potere gioca su più livelli e spesso ciò che appare evidente è solo lo strato superficiale di qualcosa di più profondo. Per avvicinarci alla verità, è fondamentale mettere insieme i pezzi, individuare le connessioni che non vengono mai evidenziate dai media e lavorare sui dettagli più piccoli, che sfuggono all’osservazione perché in apparenza insignificanti. La ricerca della verità è, pertanto, un esercizio di riflessione, di attenzione ai dettagli e soprattutto di logica; logica storica, in particolare, che ci viene in aiuto quando tutte le false ipotesi legate alla narrazione ufficiale cadono una ad una e lasciano aperte, al massimo, solo una o due possibilità, spesso complementari e intrecciate tra loro, ma sicuramente plausibili. Sempre più spesso, infatti, sono i risultati storici susseguenti a certe scelte a suggerire la verità dei “perché” (quelle stesse scelte sono state fatte), lasciando coperta spesso la verità dei “chi” (quelle stesse scelte ha fortemente voluto). Così analizzando i fatti, i dettagli trovano miracolosamente una loro collocazione, come in un puzzle dalle tessere mancanti, e tutto nel tempo diventa più chiaro.
 Per esempio, in tema di dettagli nessuno ha mai fatto notare l’assurda decisione di non emettere banconote da 1 e 2 euro, preferendo ad esse le monete. Eppure, fino al giorno prima in Italia circolavano banconote da 1.000, 2.000 e 5.000 Lire. Con le “milline” ci pagavi il parcheggiatore abusivo, oppure una pizzetta, un cono gelato, un uovo Kinder, 4 bustine di figurine Panini, le Big Babol, una lattina di Coca-Cola, un Mars, un tubetto di Smarties; con le 2.000 lire cappuccino e cornetto, tra le altre cose; con le 5.000 lire mettevi la miscela nel motorino e ci camminavi una settimana, tanto per dire. Insomma, a livello reale (potere d’acquisto) e cognitivo, l’uso delle banconote di quel valore era legato indissolubilmente all’acquisto di beni di largo consumo per i quali, dopo sole sei settimane dell’ingresso in circolazione delle “monetine”, ci volle esattamente il doppio.
Per esempio, in tema di dettagli nessuno ha mai fatto notare l’assurda decisione di non emettere banconote da 1 e 2 euro, preferendo ad esse le monete. Eppure, fino al giorno prima in Italia circolavano banconote da 1.000, 2.000 e 5.000 Lire. Con le “milline” ci pagavi il parcheggiatore abusivo, oppure una pizzetta, un cono gelato, un uovo Kinder, 4 bustine di figurine Panini, le Big Babol, una lattina di Coca-Cola, un Mars, un tubetto di Smarties; con le 2.000 lire cappuccino e cornetto, tra le altre cose; con le 5.000 lire mettevi la miscela nel motorino e ci camminavi una settimana, tanto per dire. Insomma, a livello reale (potere d’acquisto) e cognitivo, l’uso delle banconote di quel valore era legato indissolubilmente all’acquisto di beni di largo consumo per i quali, dopo sole sei settimane dell’ingresso in circolazione delle “monetine”, ci volle esattamente il doppio.
 Non c’è dubbio, quindi, che questo “dettaglio” delle monetine, passato del tutto inosservato – anzi, tutti felici a comprare i porta-euro da tasca – sia stato la causa di numerose distorsioni cognitive nei cittadini sul reale valore dell’euro e, soprattutto in Italia, abbia causato un aumento dei prezzi al consumo indotto, per così dire, da queste distorsioni e da chi se n’è approfittato. La domanda vera è: le neonate autorità europee e, soprattutto, i c.d. tecnici che “fabbricano” le decisioni, erano al corrente di questa possibilità e hanno clamorosamente fallito, oppure è sbagliata l’interpretazione a posteriori del dettaglio? Secondo gli economisti più accreditati, il passaggio dalla lira all’euro ha creato diverse distorsioni percettive, e la decisione di non emettere banconote da 1 e 2 euro ha sicuramente giocato un ruolo in questo processo. Infatti, le neuroscienze e la psicologia economica dimostrano che il formato della valuta influenza la
Non c’è dubbio, quindi, che questo “dettaglio” delle monetine, passato del tutto inosservato – anzi, tutti felici a comprare i porta-euro da tasca – sia stato la causa di numerose distorsioni cognitive nei cittadini sul reale valore dell’euro e, soprattutto in Italia, abbia causato un aumento dei prezzi al consumo indotto, per così dire, da queste distorsioni e da chi se n’è approfittato. La domanda vera è: le neonate autorità europee e, soprattutto, i c.d. tecnici che “fabbricano” le decisioni, erano al corrente di questa possibilità e hanno clamorosamente fallito, oppure è sbagliata l’interpretazione a posteriori del dettaglio? Secondo gli economisti più accreditati, il passaggio dalla lira all’euro ha creato diverse distorsioni percettive, e la decisione di non emettere banconote da 1 e 2 euro ha sicuramente giocato un ruolo in questo processo. Infatti, le neuroscienze e la psicologia economica dimostrano che il formato della valuta influenza la  percezione del suo valore. In altre parole, le persone tendono a spendere più facilmente le monete rispetto alle banconote perché le prime sono percepite come “spiccioli”, quindi di minor valore. E così, quando l’euro entrò in circolazione nel 2002, molti beni di uso quotidiano (caffè, giornali, pane, ecc.) che prima costavano l’equivalente di 500 o 1000 lire furono arrotondati a 1 euro o più. Questo fenomeno – noto come “inflazione non percepita” – si deve in parte proprio al fatto che 1 e 2 euro erano monete e non banconote, rendendo gli aumenti meno evidenti e più facilmente accettabili dai consumatori.
percezione del suo valore. In altre parole, le persone tendono a spendere più facilmente le monete rispetto alle banconote perché le prime sono percepite come “spiccioli”, quindi di minor valore. E così, quando l’euro entrò in circolazione nel 2002, molti beni di uso quotidiano (caffè, giornali, pane, ecc.) che prima costavano l’equivalente di 500 o 1000 lire furono arrotondati a 1 euro o più. Questo fenomeno – noto come “inflazione non percepita” – si deve in parte proprio al fatto che 1 e 2 euro erano monete e non banconote, rendendo gli aumenti meno evidenti e più facilmente accettabili dai consumatori.
 L’UE era consapevole di questo effetto? È difficile pensare che economisti e tecnocrati di Bruxelles non fossero a conoscenza di queste dinamiche psicologiche dei consumi. Alcuni studi sul comportamento dei consumatori avevano già evidenziato il cosiddetto “effetto soglia“, per cui le persone sono meno sensibili agli aumenti quando il mezzo di pagamento è meno “pesante” psicologicamente. Inoltre, già durante la transizione all’euro, si parlava del rischio che gli esercenti approfittassero dell’arrotondamento per far salire i prezzi, cosa che poi è effettivamente successa in diversi Paesi; ma soprattutto in Italia, dove la lira aveva valori nominali molto più alti e il cambio con l’euro era particolarmente sfavorevole (1 euro = 1936,27 lire).
L’UE era consapevole di questo effetto? È difficile pensare che economisti e tecnocrati di Bruxelles non fossero a conoscenza di queste dinamiche psicologiche dei consumi. Alcuni studi sul comportamento dei consumatori avevano già evidenziato il cosiddetto “effetto soglia“, per cui le persone sono meno sensibili agli aumenti quando il mezzo di pagamento è meno “pesante” psicologicamente. Inoltre, già durante la transizione all’euro, si parlava del rischio che gli esercenti approfittassero dell’arrotondamento per far salire i prezzi, cosa che poi è effettivamente successa in diversi Paesi; ma soprattutto in Italia, dove la lira aveva valori nominali molto più alti e il cambio con l’euro era particolarmente sfavorevole (1 euro = 1936,27 lire).
 Tuttavia, non ci fu una vera strategia europea per contenere questi effetti. L’UE , notoriamente “asfissiante” sulle politiche di controllo della finanza dell’Unione, lasciò ai singoli Stati la gestione della transizione, e in Italia mancò un controllo efficace sui prezzi. In Germania e Francia, per esempio, ci furono campagne informative più forti e maggiori controlli sui rincari. Fu errore o scelta deliberata? Qui sta il punto cruciale: se fosse stato un errore, l’UE avrebbe dovuto correggerlo negli anni successivi, magari introducendo banconote da 1 e 2 euro per mitigare l’effetto percettivo. Se fosse stata una scelta deliberata, allora si potrebbe ipotizzare che l’inflazione indotta fosse considerata un effetto collaterale accettabile, o addirittura utile per accelerare l’adattamento all’euro e ridurre il valore reale dei salari senza doverlo fare con riforme impopolari. Difficile avere una prova definitiva, ma il fatto che l’UE non sia mai intervenuta per correggere questa distorsione fa pensare che fosse almeno un effetto previsto, se non proprio desiderato. E questo ce lo dice la logica “storica” usata per arrivare alla verità rivelata da un semplice dettaglio.
Tuttavia, non ci fu una vera strategia europea per contenere questi effetti. L’UE , notoriamente “asfissiante” sulle politiche di controllo della finanza dell’Unione, lasciò ai singoli Stati la gestione della transizione, e in Italia mancò un controllo efficace sui prezzi. In Germania e Francia, per esempio, ci furono campagne informative più forti e maggiori controlli sui rincari. Fu errore o scelta deliberata? Qui sta il punto cruciale: se fosse stato un errore, l’UE avrebbe dovuto correggerlo negli anni successivi, magari introducendo banconote da 1 e 2 euro per mitigare l’effetto percettivo. Se fosse stata una scelta deliberata, allora si potrebbe ipotizzare che l’inflazione indotta fosse considerata un effetto collaterale accettabile, o addirittura utile per accelerare l’adattamento all’euro e ridurre il valore reale dei salari senza doverlo fare con riforme impopolari. Difficile avere una prova definitiva, ma il fatto che l’UE non sia mai intervenuta per correggere questa distorsione fa pensare che fosse almeno un effetto previsto, se non proprio desiderato. E questo ce lo dice la logica “storica” usata per arrivare alla verità rivelata da un semplice dettaglio.
 C’era una strategia più ampia dietro? In molti sapevano, e il non aver voluto riparare all’errore, anche a posteriori, fa pensare ad una regia dietro, che tramava per indebolire l’Italia, che allora era la sesta potenza mondiale, con una strategia di lungo termine, e il ruolo odierno dell’Italia nello scacchiere internazionale ne sarebbe la prova. Questa verità, che nel 2000 sarebbe apparsa come frutto di complottismo e forse sarebbe stata derisa, oggi rivela tutta la sua forza e le sue solide basi logiche. L’Italia, prima dell’introduzione dell’euro, era una delle principali potenze industriali del mondo, con un settore manifatturiero tra i più forti a livello globale e una capacità produttiva che faceva concorrenza diretta a Germania e Francia. Il declino relativo dell’Italia negli ultimi vent’anni potrebbe quindi non essere stato solo il risultato di errori interni, ma anche di un progetto più ampio.
C’era una strategia più ampia dietro? In molti sapevano, e il non aver voluto riparare all’errore, anche a posteriori, fa pensare ad una regia dietro, che tramava per indebolire l’Italia, che allora era la sesta potenza mondiale, con una strategia di lungo termine, e il ruolo odierno dell’Italia nello scacchiere internazionale ne sarebbe la prova. Questa verità, che nel 2000 sarebbe apparsa come frutto di complottismo e forse sarebbe stata derisa, oggi rivela tutta la sua forza e le sue solide basi logiche. L’Italia, prima dell’introduzione dell’euro, era una delle principali potenze industriali del mondo, con un settore manifatturiero tra i più forti a livello globale e una capacità produttiva che faceva concorrenza diretta a Germania e Francia. Il declino relativo dell’Italia negli ultimi vent’anni potrebbe quindi non essere stato solo il risultato di errori interni, ma anche di un progetto più ampio.
 Tutto questo, però, andrebbe provato con elementi che supportano l’ipotesi. Eccone alcuni:
Tutto questo, però, andrebbe provato con elementi che supportano l’ipotesi. Eccone alcuni:
1. il tasso di conversione della lira fu fissato a 1936,27 lire per un euro, un valore che molti economisti ritenevano sopravvalutato. Questo rese le esportazioni italiane più costose rispetto a quelle tedesche, penalizzando la competitività dell’industria italiana. La Germania, invece, beneficiò di un euro “debole” rispetto al vecchio marco, favorendo il suo surplus commerciale;
2. l’Italia è stata tra i Paesi più penalizzati dalle rigide regole di bilancio dell’UE (Patto di Stabilità e Fiscal Compact), che hanno impedito investimenti pubblici e ridotto la capacità di crescita del Paese. La Germania, nel frattempo, violò gli stessi vincoli nel periodo della riunificazione senza subire conseguenze;
 3. molte grandi aziende italiane sono state acquisite da gruppi stranieri (Fiat ha spostato la sede nei Paesi Bassi, Pirelli è passata ai cinesi, Parmalat ai francesi, ecc.). Settori chiave come l’energia e le telecomunicazioni hanno subito pressioni politiche e finanziarie per essere ridimensionati o venduti. L’Italia è passata dall’essere una potenza manifatturiera a un Paese con un’economia sempre più basata su servizi e turismo, con meno peso strategico;
3. molte grandi aziende italiane sono state acquisite da gruppi stranieri (Fiat ha spostato la sede nei Paesi Bassi, Pirelli è passata ai cinesi, Parmalat ai francesi, ecc.). Settori chiave come l’energia e le telecomunicazioni hanno subito pressioni politiche e finanziarie per essere ridimensionati o venduti. L’Italia è passata dall’essere una potenza manifatturiera a un Paese con un’economia sempre più basata su servizi e turismo, con meno peso strategico;
4. la speculazione contro i titoli di Stato italiani (crisi dello spread 2011) ha mostrato quanto facilmente l’Italia potesse essere messa sotto pressione dai mercati, con un’azione che favorì il cambio di governo. I governi tecnici e le riforme imposte dall’esterno hanno ridotto lo spazio di manovra politica, consolidando la dipendenza dell’Italia da Bruxelles e dalla BCE.
 Questi dettagli, tuttavia, non spiegano il movente: perché indebolire l’Italia? E’ presto detto. Se l’Italia avesse mantenuto la sua forza economica e industriale, avrebbe potuto essere un terzo polo nell’UE, capace di bilanciare il dominio franco-tedesco. Invece, con un’economia più fragile e più dipendente dall’UE, la sua influenza geopolitica si è ridotta drasticamente. In sintesi, sembra una strategia di lungo termine, in cui diversi Paesi europei hanno tratto vantaggio dall’indebolimento italiano:
Questi dettagli, tuttavia, non spiegano il movente: perché indebolire l’Italia? E’ presto detto. Se l’Italia avesse mantenuto la sua forza economica e industriale, avrebbe potuto essere un terzo polo nell’UE, capace di bilanciare il dominio franco-tedesco. Invece, con un’economia più fragile e più dipendente dall’UE, la sua influenza geopolitica si è ridotta drasticamente. In sintesi, sembra una strategia di lungo termine, in cui diversi Paesi europei hanno tratto vantaggio dall’indebolimento italiano:
– la Germania ha consolidato il suo dominio industriale;
– la Francia ha rafforzato la sua presenza economica in Italia;
– le istituzioni europee hanno trovato più facile imporre politiche eccessivamente severe imponendo la rigida visione dei Paesi c.d. frugali contro il meridione d’Europa e, soprattutto, contro un’Italia militarmente ancora nelle mani degli Stati Uniti ma industrialmente forte, pronta a fare da possibile contrappeso. Adesso, però, abbiamo superato il punto di non ritorno: l’Italia non ha alcun margine per ribaltare questa situazione, e non esistono forze interne ed esterne (USA) capaci di consentire al nostro Paese di reagire ad una dipendenza irreversibile dall’UE e dai mercati finanziari.
Questa è l’ultima verità di oggi, ed è la peggiore di tutte.



 Purtroppo, sul tema della informazione-disinformazione di massa il mondo sta vivendo sulla propria pelle la scomparsa del vero giornalismo indipendente (quello degli anni ’60, ’70, ’80 e primi anni ’90), decentrato e libero dai condizionamenti dei grandi gruppi industriali, e sta subendo “l’esperienza” della informazione accentrata, ossia quella decisa a tavolino ogni giorno dai pochi soggetti proprietari dei più influenti canali media del mondo (RTL Group, News Corporation, NBC e Viacom, TF1), i quali hanno da tempo adottato la strategia di Goebbelsiana memoria della diffusione ossessiva di notizie asservite ad alcune correnti di pensiero dominante e strumentali agli interessi economici (o anche militari) dei più grandi players finanziari e governativi (USA in cima).
Purtroppo, sul tema della informazione-disinformazione di massa il mondo sta vivendo sulla propria pelle la scomparsa del vero giornalismo indipendente (quello degli anni ’60, ’70, ’80 e primi anni ’90), decentrato e libero dai condizionamenti dei grandi gruppi industriali, e sta subendo “l’esperienza” della informazione accentrata, ossia quella decisa a tavolino ogni giorno dai pochi soggetti proprietari dei più influenti canali media del mondo (RTL Group, News Corporation, NBC e Viacom, TF1), i quali hanno da tempo adottato la strategia di Goebbelsiana memoria della diffusione ossessiva di notizie asservite ad alcune correnti di pensiero dominante e strumentali agli interessi economici (o anche militari) dei più grandi players finanziari e governativi (USA in cima). In tutta evidenza, i timori dei vari organismi antitrust sulle limitazioni alla libertà di stampa generate dalle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore dei media erano fondati e, com’era stato previsto, alla eccessiva concentrazione industriale di aziende editoriali e televisive è seguita la nascita del fenomeno della informazione accentrata e non più “libera”. All’interno di questo scenario illiberale, negli anni scorsi ha trovato strada facile il “mantra” del presunto gender pay gap retributivo ai danni delle donne, che nella sua prima versione (“…le donne guadagnano meno degli uomini a parità di mansioni…”) è stato presto smascherato come una delle peggiori bufale di questo millennio. Infatti, le norme che vietano di pagare un lavoratore meno di un altro a parità di mansioni e grado, sia nel settore pubblico che in quello privato, sono rigidamente osservate da tutti i datori di lavoro in Italia e nel mondo occidentale (provate a trovare una insegnante o una operaia che guadagnano meno dei colleghi uomini con uguali mansioni e anzianità di servizio…).
In tutta evidenza, i timori dei vari organismi antitrust sulle limitazioni alla libertà di stampa generate dalle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) nel settore dei media erano fondati e, com’era stato previsto, alla eccessiva concentrazione industriale di aziende editoriali e televisive è seguita la nascita del fenomeno della informazione accentrata e non più “libera”. All’interno di questo scenario illiberale, negli anni scorsi ha trovato strada facile il “mantra” del presunto gender pay gap retributivo ai danni delle donne, che nella sua prima versione (“…le donne guadagnano meno degli uomini a parità di mansioni…”) è stato presto smascherato come una delle peggiori bufale di questo millennio. Infatti, le norme che vietano di pagare un lavoratore meno di un altro a parità di mansioni e grado, sia nel settore pubblico che in quello privato, sono rigidamente osservate da tutti i datori di lavoro in Italia e nel mondo occidentale (provate a trovare una insegnante o una operaia che guadagnano meno dei colleghi uomini con uguali mansioni e anzianità di servizio…).  Qualcuno un po’ più sveglio, resosi conto che la bufala si scontrava con il dato di realtà di milioni di lavoratori e, quindi, faceva acqua da tutte le parti, si è affrettato a correggere la rotta chiarendo che il (sempre presunto) gender pay gap retributivo non è un problema individuale, ma “di categoria”, nel senso che l’insieme delle donne lavoratrici ha un aggregato retributivo – in termini assoluti – inferiore a quello relativo all’insieme degli uomini che lavorano, dimenticandosi però di specificare che tale stato di cose non è certo frutto di “discriminazione reddituale” ai danni delle singole donne (o peggio ancora del loro insieme) ma il naturale portato di una serie di fattori socio-economici (maggiore ricorso al part-time da parte delle lavoratrici, rinuncia
Qualcuno un po’ più sveglio, resosi conto che la bufala si scontrava con il dato di realtà di milioni di lavoratori e, quindi, faceva acqua da tutte le parti, si è affrettato a correggere la rotta chiarendo che il (sempre presunto) gender pay gap retributivo non è un problema individuale, ma “di categoria”, nel senso che l’insieme delle donne lavoratrici ha un aggregato retributivo – in termini assoluti – inferiore a quello relativo all’insieme degli uomini che lavorano, dimenticandosi però di specificare che tale stato di cose non è certo frutto di “discriminazione reddituale” ai danni delle singole donne (o peggio ancora del loro insieme) ma il naturale portato di una serie di fattori socio-economici (maggiore ricorso al part-time da parte delle lavoratrici, rinuncia  volontaria di molte donne ai percorsi di carriera, scarsa preferenza delle donne verso il lavoro autonomo, etc) che con la discriminazione non c’entrano nulla. Eppure, nonostante ciò, la propaganda ossessiva centrata sulla bugia che “le donne che fanno lo stesso lavoro degli uomini guadagnano meno di loro” fa fatica ad essere rimossa, ed ha finito per trascinarsi fino al calcio professionistico, dove i fattori industriali che regolano le logiche retributive di calciatori e calciatrici sono universalmente accettate e sorrette da basilari principi di economia aziendale.
volontaria di molte donne ai percorsi di carriera, scarsa preferenza delle donne verso il lavoro autonomo, etc) che con la discriminazione non c’entrano nulla. Eppure, nonostante ciò, la propaganda ossessiva centrata sulla bugia che “le donne che fanno lo stesso lavoro degli uomini guadagnano meno di loro” fa fatica ad essere rimossa, ed ha finito per trascinarsi fino al calcio professionistico, dove i fattori industriali che regolano le logiche retributive di calciatori e calciatrici sono universalmente accettate e sorrette da basilari principi di economia aziendale. Naturalmente, non tutte le grandezze economiche alla base delle varie discipline sportive maschili e femminili sono così distanti tra loro come nel calcio. Nel Tennis femminile, per esempio, le giocatrici fin dagli anni ’50 si sono fatte strada anche nel mondo degli sponsor e dei media, riuscendo ad ottenere grande visibilità e un ottimo seguito da parte degli appassionati di entrambi i generi. Ciò ha permesso col tempo alle federazioni tennistiche femminili (riunite nel WTA) di imporre agli organizzatori dei tornei l’assoluta parità dei premi per uomini e donne sia in caso di vittoria che nelle fasi eliminatorie intermedie, ma tutto questo è stato possibile grazie al fatturato e ai benefici reputazionali che il tennis femminile – oggi quasi al pari di quello maschile – assicura rispettivamente ai media (introiti pubblicitari, abbonati) e agli sponsor (autorevolezza del brand e vendite al dettaglio).
Naturalmente, non tutte le grandezze economiche alla base delle varie discipline sportive maschili e femminili sono così distanti tra loro come nel calcio. Nel Tennis femminile, per esempio, le giocatrici fin dagli anni ’50 si sono fatte strada anche nel mondo degli sponsor e dei media, riuscendo ad ottenere grande visibilità e un ottimo seguito da parte degli appassionati di entrambi i generi. Ciò ha permesso col tempo alle federazioni tennistiche femminili (riunite nel WTA) di imporre agli organizzatori dei tornei l’assoluta parità dei premi per uomini e donne sia in caso di vittoria che nelle fasi eliminatorie intermedie, ma tutto questo è stato possibile grazie al fatturato e ai benefici reputazionali che il tennis femminile – oggi quasi al pari di quello maschile – assicura rispettivamente ai media (introiti pubblicitari, abbonati) e agli sponsor (autorevolezza del brand e vendite al dettaglio). L’oggetto di contesa riguarda, come dicevamo, il calcio femminile, dove le cose ad oggi sono andate molto diversamente rispetto al tennis o ad altre discipline (volley e atletica, per esempio). Ad alzare il tono della polemica era stata, qualche settimana fa, la calciatrice svizzera L’attaccante svizzera Alisha Lehmann, compagna del calciatore di serie A Douglas Ruiz (Juventus), la quale in occasione di diverse interviste ha affermato che “…io e Douglas facciamo lo stesso lavoro ma lui guadagna cento volte più di me. Il Mondiale femminile è stata la quinta manifestazione sportiva più vista al mondo, per cui è chiaro che noi donne dobbiamo avere la stessa retribuzione del calcio maschile…”. Peccato che, nel mondo del calcio (così come di tutti gli sport), contano i ricavi industriali, che il calcio maschile produce in misura mediamente pari a dieci volte quelli femminili. Ciò spiega perchè le calciatrici oggi sono pagate di meno degli uomini, e ciò spiega perché le cose staranno così finché i ricavi industriali del calcio femminile non saranno tali da consentire una meritata eguaglianza.
L’oggetto di contesa riguarda, come dicevamo, il calcio femminile, dove le cose ad oggi sono andate molto diversamente rispetto al tennis o ad altre discipline (volley e atletica, per esempio). Ad alzare il tono della polemica era stata, qualche settimana fa, la calciatrice svizzera L’attaccante svizzera Alisha Lehmann, compagna del calciatore di serie A Douglas Ruiz (Juventus), la quale in occasione di diverse interviste ha affermato che “…io e Douglas facciamo lo stesso lavoro ma lui guadagna cento volte più di me. Il Mondiale femminile è stata la quinta manifestazione sportiva più vista al mondo, per cui è chiaro che noi donne dobbiamo avere la stessa retribuzione del calcio maschile…”. Peccato che, nel mondo del calcio (così come di tutti gli sport), contano i ricavi industriali, che il calcio maschile produce in misura mediamente pari a dieci volte quelli femminili. Ciò spiega perchè le calciatrici oggi sono pagate di meno degli uomini, e ciò spiega perché le cose staranno così finché i ricavi industriali del calcio femminile non saranno tali da consentire una meritata eguaglianza. Per spiegare meglio il concetto, ecco un esempio: i ricavi dell’ultimo campionato europeo di calcio maschile sono stati pari a 4,3 miliardi di euro, mentre quelli dell’ultimo campionato europeo di calcio femminile sono stati di 140 milioni di euro; le retribuzioni delle calciatrici, però, sono state pari a circa 30 milioni, ossia più del 20% del monte ricavi, mentre quelle dei calciatori circa 300 milioni di euro, ossia il 7% del totale dei ricavi. Ebbene, se è vero che, in valore assoluto, i giocatori hanno guadagnato nel complesso 10 volte più delle giocatrici, è anche vero che il fatturato del calcio europeo maschile è stato pari a 30 volte rispetto a quello femminile. Pertanto, chiedere oggi per le calciatrici professioniste la parità “politica” di retribuzione sulla base di queste enormi disparità di ricavi nei rispettivi settori, equivarrebbe a voler far fallire tutte le federazioni sportive del mondo.
Per spiegare meglio il concetto, ecco un esempio: i ricavi dell’ultimo campionato europeo di calcio maschile sono stati pari a 4,3 miliardi di euro, mentre quelli dell’ultimo campionato europeo di calcio femminile sono stati di 140 milioni di euro; le retribuzioni delle calciatrici, però, sono state pari a circa 30 milioni, ossia più del 20% del monte ricavi, mentre quelle dei calciatori circa 300 milioni di euro, ossia il 7% del totale dei ricavi. Ebbene, se è vero che, in valore assoluto, i giocatori hanno guadagnato nel complesso 10 volte più delle giocatrici, è anche vero che il fatturato del calcio europeo maschile è stato pari a 30 volte rispetto a quello femminile. Pertanto, chiedere oggi per le calciatrici professioniste la parità “politica” di retribuzione sulla base di queste enormi disparità di ricavi nei rispettivi settori, equivarrebbe a voler far fallire tutte le federazioni sportive del mondo.
 Un altro esempio pratico chiarirà ancor di più la questione. Si stima che il calcio maschile, nel suo insieme, generi un indotto annuo di circa 25 miliardi di euro solo in Europa, e si sa che i calciatori della massima serie dei vari campionati nazionali arrivino a guadagnare in media 10 milioni di euro all’anno ciascuno, ossia in media lo 0,04% in rapporto all’indotto totale; il calcio femminile europeo, al contrario, genera circa 0,7 miliardi (700 milioni) di euro di indotto all’anno, ma le migliori calciatrici guadagnano fino a 500.000 euro l’anno, ossia lo 0,07% dell’indotto, che è quasi il doppio del dato riferito al calcio maschile. Tutto questo spiega l’impossibilità di poter accogliere anche “in teoria” qualunque istanza di parità retributiva, il cui raggiungimento è augurabile ma sotto gli auspici del rispetto del principio del “neminem leadere”: il calcio femminile, anziché auspicare una riduzione “politica” degli stipendi dei calciatori, investa su sé stesso, in modo da colmare negli anni il “gap sportivo” e raggiungere la parità retributiva nel rispetto del criterio meritocratico già applicato con successo in altre discipline (Sci, Volley, Atletica, Tennis etc).
Un altro esempio pratico chiarirà ancor di più la questione. Si stima che il calcio maschile, nel suo insieme, generi un indotto annuo di circa 25 miliardi di euro solo in Europa, e si sa che i calciatori della massima serie dei vari campionati nazionali arrivino a guadagnare in media 10 milioni di euro all’anno ciascuno, ossia in media lo 0,04% in rapporto all’indotto totale; il calcio femminile europeo, al contrario, genera circa 0,7 miliardi (700 milioni) di euro di indotto all’anno, ma le migliori calciatrici guadagnano fino a 500.000 euro l’anno, ossia lo 0,07% dell’indotto, che è quasi il doppio del dato riferito al calcio maschile. Tutto questo spiega l’impossibilità di poter accogliere anche “in teoria” qualunque istanza di parità retributiva, il cui raggiungimento è augurabile ma sotto gli auspici del rispetto del principio del “neminem leadere”: il calcio femminile, anziché auspicare una riduzione “politica” degli stipendi dei calciatori, investa su sé stesso, in modo da colmare negli anni il “gap sportivo” e raggiungere la parità retributiva nel rispetto del criterio meritocratico già applicato con successo in altre discipline (Sci, Volley, Atletica, Tennis etc).

 La consulenza limitata ai soli valori mobiliari limita fortemente il livello di comprensione delle esigenze personali, familiari, aziendali, culturali e sociali presenti nella società moderna, e spesso nega al consulente finanziario – così come alle altre professioni impegnate su tematiche patrimoniali – le migliori sinergie di lavoro; in particolare nel segmento delle famiglie ben patrimonializzate, professionalmente di grande interesse ma seguite da singole individualità, non legate tra loro da alcuna forma di collaborazione, e dai canali bancari tradizionali. Pertanto, anche gli altri professionisti che intervengono a vario titolo sui temi del patrimonio – tra gli altri: avvocati, commercialisti, notai, assicuratori e agenti immobiliari – non hanno l’opportunità di avere una visione d’insieme della Consulenza Patrimoniale Integrata, l’unica capace di farli uscire dal proprio “isolamento professionale” e di aprire per loro nuovi mercati, grazie al lavoro in team con i consulenti finanziari.
La consulenza limitata ai soli valori mobiliari limita fortemente il livello di comprensione delle esigenze personali, familiari, aziendali, culturali e sociali presenti nella società moderna, e spesso nega al consulente finanziario – così come alle altre professioni impegnate su tematiche patrimoniali – le migliori sinergie di lavoro; in particolare nel segmento delle famiglie ben patrimonializzate, professionalmente di grande interesse ma seguite da singole individualità, non legate tra loro da alcuna forma di collaborazione, e dai canali bancari tradizionali. Pertanto, anche gli altri professionisti che intervengono a vario titolo sui temi del patrimonio – tra gli altri: avvocati, commercialisti, notai, assicuratori e agenti immobiliari – non hanno l’opportunità di avere una visione d’insieme della Consulenza Patrimoniale Integrata, l’unica capace di farli uscire dal proprio “isolamento professionale” e di aprire per loro nuovi mercati, grazie al lavoro in team con i consulenti finanziari. In tal senso, quella del Consulente Finanziario e Patrimoniale è l’unica figura di leadership capace di “mettere in rete” la competenza di ciascuna di queste categorie professionali, trasformandole in “generatori di opportunità”. “Aver accumulato individualmente specifiche esperienze didattiche e professionali in materia di Consulenza Patrimoniale Integrata – affermano Manlio Marucci* e Alessio Cardinale**, coordinatori didattici del Master – ci ha permesso di promuovere all’interno del Consorzio Universitario Humanitas e dell’Università San Raffaele di Roma il Master Universitario di primo livello “Consulente Finanziario e Patrimoniale“, anticipando così la domanda formativa che nei prossimi anni arriverà da parte degli iscritti ad alcune categorie professionali in fase di profonda e rapida trasformazione, come quella del consulente finanziario“.
In tal senso, quella del Consulente Finanziario e Patrimoniale è l’unica figura di leadership capace di “mettere in rete” la competenza di ciascuna di queste categorie professionali, trasformandole in “generatori di opportunità”. “Aver accumulato individualmente specifiche esperienze didattiche e professionali in materia di Consulenza Patrimoniale Integrata – affermano Manlio Marucci* e Alessio Cardinale**, coordinatori didattici del Master – ci ha permesso di promuovere all’interno del Consorzio Universitario Humanitas e dell’Università San Raffaele di Roma il Master Universitario di primo livello “Consulente Finanziario e Patrimoniale“, anticipando così la domanda formativa che nei prossimi anni arriverà da parte degli iscritti ad alcune categorie professionali in fase di profonda e rapida trasformazione, come quella del consulente finanziario“.
 Tutti i partecipanti al Master frequenteranno un calendario di lezioni fruibili in diretta su piattaforma Zoom (modalità FAD asincrona/sincrona), dalla durata complessiva di 1.500 ore tra lezioni, project work, prove di verifica, studio individuale, tirocinio (online e/o presenza) ed esercitazioni con prova finale. Alla fine del percorso di formazione, il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma rilasceranno a ciascun partecipante un diploma di master universitario di primo livello.
Tutti i partecipanti al Master frequenteranno un calendario di lezioni fruibili in diretta su piattaforma Zoom (modalità FAD asincrona/sincrona), dalla durata complessiva di 1.500 ore tra lezioni, project work, prove di verifica, studio individuale, tirocinio (online e/o presenza) ed esercitazioni con prova finale. Alla fine del percorso di formazione, il Consorzio Universitario Humanitas e l’Università San Raffaele di Roma rilasceranno a ciascun partecipante un diploma di master universitario di primo livello. 
 Infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà.
Infatti, in tema di assegnazione della casa coniugale neanche il valore locativo dell’immobile assegnato viene riconosciuto quale compensazione economica (almeno parziale) di quanto stabilito come alimenti per l’ex coniuge, quando spettanti. La circostanza è piuttosto grave, poiché l’assegnazione della casa coniugale ad un solo soggetto – che molto spesso non è nemmeno il comproprietario dell’immobile – per via della sua lunga durata (anche tutta la vita) determina una gravissima compressione del diritto di proprietà. A testimonianza della perdita di fatto del titolo di proprietà o comproprietà – che si supporrebbe temporaneo, ma nessun giudice stabilisce un termine e l’assegnazione dura praticamente tutta la vita – secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione l’ex marito che entra nella casa assegnata alla moglie dopo la separazione rischia una condanna per violazione di domicilio, anche se ne è proprietario o comproprietario. In sintesi, grazie alle decisioni dei tribunali civili, le ex mogli (molto raramente gli ex mariti) diventano titolari esclusive del diritto di abitare l’appartamento, e in virtù dello ius excludendi alios hanno il diritto di decidere chi può avere accesso alla casa, anche se l’ex marito continua ad esserne proprietario o comproprietario.
A testimonianza della perdita di fatto del titolo di proprietà o comproprietà – che si supporrebbe temporaneo, ma nessun giudice stabilisce un termine e l’assegnazione dura praticamente tutta la vita – secondo diverse pronunce della Corte di Cassazione l’ex marito che entra nella casa assegnata alla moglie dopo la separazione rischia una condanna per violazione di domicilio, anche se ne è proprietario o comproprietario. In sintesi, grazie alle decisioni dei tribunali civili, le ex mogli (molto raramente gli ex mariti) diventano titolari esclusive del diritto di abitare l’appartamento, e in virtù dello ius excludendi alios hanno il diritto di decidere chi può avere accesso alla casa, anche se l’ex marito continua ad esserne proprietario o comproprietario. La questione, quindi, assume nel tempo i contorni di una requisizione a termine indefinito, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo a valere sul mantenimento o sui beni della ex moglie assegnataria, soprattutto allorquando anche lei è titolare di un reddito o di beni fungibili di buon valore economico (immobili, preziosi, depositi bancari etc). Infatti, in tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’esecuzione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, che nasce dal principio di responsabilità patrimoniale ed è diretto a sottrarre al
La questione, quindi, assume nel tempo i contorni di una requisizione a termine indefinito, per la quale andrebbe riconosciuto a chi la subisce un giusto indennizzo economico o un equo valore compensativo a valere sul mantenimento o sui beni della ex moglie assegnataria, soprattutto allorquando anche lei è titolare di un reddito o di beni fungibili di buon valore economico (immobili, preziosi, depositi bancari etc). Infatti, in tema di privazione forzosa dall’utilizzo dei propri beni, il Diritto ci dice che l’esecuzione forzata è un procedimento esecutivo, di natura coattiva, che nasce dal principio di responsabilità patrimoniale ed è diretto a sottrarre al  debitore determinati beni (pignorabili) al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta di proprietà) di un bene, ed è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per il superiore interesse pubblico contro il pagamento di un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo.
debitore determinati beni (pignorabili) al fine di soddisfare il creditore procedente (articolo 2740 Codice Civile). La requisizione, invece, è l’atto giuridico con cui si priva un soggetto dei suoi diritti di possesso (e talvolta di proprietà) di un bene, ed è un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione sottrae al privato, in via temporanea o definitiva, il godimento di un bene per il superiore interesse pubblico contro il pagamento di un indennizzo. Nel diritto penale, infine, la confisca è l’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell’intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo. Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti:
Orbene, nel caso dell’assegnazione della casa coniugale il giudice che la dispone non fa alcuna menzione del fondamentale requisito del periodo di tempo massimo a cui dovrebbe necessariamente sottostare; di conseguenza, risulta impossibile catalogare tale istituto all’interno di una fattispecie giuridicamente prevedibile e perfetta, dal momento che, senza la definizione di un limite temporale ben definito, non ha alcuna fonte nel diritto se non nella giurisprudenza di merito. Infatti: accuratamente inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione FUTURA che farebbe scattare eventuali e successive azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi);
accuratamente inapplicato nei tribunali di merito, l’obbligo alimentare viene generalmente assolto a mezzo assegno (di norma mensile), ed è la sua mancata corresponsione FUTURA che farebbe scattare eventuali e successive azioni esecutive (es. pignoramenti presso terzi); In considerazione dell’assenza di un termine temporale, della sua lunghissima durata e della mancanza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo coniuge somiglierebbero di più a quelli di un esproprio per pubblica utilità, ma nel caso dell’assegnazione della casa coniugale l’utilità insisterebbe a beneficio di una sola persona e dei figli eventualmente conviventi. Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie sia generata dal supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non sarebbe concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di
In considerazione dell’assenza di un termine temporale, della sua lunghissima durata e della mancanza di un indennizzo, gli effetti dell’assegnazione della casa ad un solo coniuge somiglierebbero di più a quelli di un esproprio per pubblica utilità, ma nel caso dell’assegnazione della casa coniugale l’utilità insisterebbe a beneficio di una sola persona e dei figli eventualmente conviventi. Qualcuno potrebbe osservare che tale particolare fattispecie sia generata dal supremo interesse del minore che abita la casa coniugale, per il quale non sarebbe concepibile l’ipotesi di un allontanamento per soggiacere agli interessi di natura patrimoniale degli adulti. Ma anche questa teoria non è efficace, perchè in molti casi di divorzio e di  susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni (anche trentenni). Il mistero, pertanto, rimane, e determina l’urgenza di legiferare una disciplina giuridica chiara e inequivocabile, che tuteli anche gli interessi legittimi dei proprietari immobiliari. La prassi odierna dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, fuoriesce dal perimetro dello Stato di Diritto democratico e finisce con il somigliare molto a una di quelle usate nei sistemi giuridici asserviti all’economia collettivista.
susseguente assegnazione esclusiva della casa coniugale non insistono minori, ma figli maggiorenni (anche trentenni). Il mistero, pertanto, rimane, e determina l’urgenza di legiferare una disciplina giuridica chiara e inequivocabile, che tuteli anche gli interessi legittimi dei proprietari immobiliari. La prassi odierna dell’assegnazione della casa coniugale, infatti, fuoriesce dal perimetro dello Stato di Diritto democratico e finisce con il somigliare molto a una di quelle usate nei sistemi giuridici asserviti all’economia collettivista.
 Pertanto, il mistero su quel tragico episodio di sport estremo rimarrà per sempre, così come gli importanti interrogativi che da esso si sono generati: gli scalatori hanno fatto bene a continuare l’impresa, nella quale avevano investito tempo, preparazione e denaro, oppure sarebbe stato giusto interrompere la scalata e attendere i soccorsi, dando allo sfortunato sherpa tutta l’assistenza possibile? E’ giusto che, per il perseguimento di un obiettivo di un gruppo di individui, anche uno solo di essi possa essere lasciato indietro, andando così incontro ad irreparabili conseguenze?
Pertanto, il mistero su quel tragico episodio di sport estremo rimarrà per sempre, così come gli importanti interrogativi che da esso si sono generati: gli scalatori hanno fatto bene a continuare l’impresa, nella quale avevano investito tempo, preparazione e denaro, oppure sarebbe stato giusto interrompere la scalata e attendere i soccorsi, dando allo sfortunato sherpa tutta l’assistenza possibile? E’ giusto che, per il perseguimento di un obiettivo di un gruppo di individui, anche uno solo di essi possa essere lasciato indietro, andando così incontro ad irreparabili conseguenze? C’è da dire che, durante scalate di questo tipo, i cosiddetti sherpa sono indispensabili: sono persone modeste, dal tenore di vita più che frugale ma di grande esperienza, che generalmente conoscono bene le montagne e si occupano per lo più dei lavori di fatica (portare l’attrezzatura pesante, montare le tende e attrezzare i percorsi prima della scalata degli alpinisti); inoltre, il loro organismo è perfettamente adattato alle altitudini e all’ossigeno rarefatto cui gli scalatori, invece, devono continuamente adattarsi prima di cominciare l’ascesa. Nonostante il loro ruolo così importante, se uno di loro è in difficoltà in un ambiente piuttosto ostile – come può essere un picco a 8.000 metri di altezza – gli scalatori sono disposti a
C’è da dire che, durante scalate di questo tipo, i cosiddetti sherpa sono indispensabili: sono persone modeste, dal tenore di vita più che frugale ma di grande esperienza, che generalmente conoscono bene le montagne e si occupano per lo più dei lavori di fatica (portare l’attrezzatura pesante, montare le tende e attrezzare i percorsi prima della scalata degli alpinisti); inoltre, il loro organismo è perfettamente adattato alle altitudini e all’ossigeno rarefatto cui gli scalatori, invece, devono continuamente adattarsi prima di cominciare l’ascesa. Nonostante il loro ruolo così importante, se uno di loro è in difficoltà in un ambiente piuttosto ostile – come può essere un picco a 8.000 metri di altezza – gli scalatori sono disposti a  sacrificarlo pur di non interrompere l’ascesa verso la vetta, sicuri di poterlo rimpiazzare in occasione di una successiva impresa. In questo senso, le vite contrapposte di scalatori e sherpa sono una metafora di qualunque universo lavorativo complesso, dove sempre più spesso persone di grande esperienza ma non di successo – secondo i parametri dei massimi dirigenti, ossia gli “scalatori” – vengono “sacrificate” senza mezzi termini e per i motivi più disparati: produttività media o appena sufficiente, età avanzata, modesti tempi di reazione all’innovazione tecnologica.
sacrificarlo pur di non interrompere l’ascesa verso la vetta, sicuri di poterlo rimpiazzare in occasione di una successiva impresa. In questo senso, le vite contrapposte di scalatori e sherpa sono una metafora di qualunque universo lavorativo complesso, dove sempre più spesso persone di grande esperienza ma non di successo – secondo i parametri dei massimi dirigenti, ossia gli “scalatori” – vengono “sacrificate” senza mezzi termini e per i motivi più disparati: produttività media o appena sufficiente, età avanzata, modesti tempi di reazione all’innovazione tecnologica. Nel caso delle reti di consulenza finanziaria, per esempio, questa metafora risulta essere davvero “azzeccata”, poichè il sistema finanziario europeo, pur di primeggiare nel mondo (in particolar modo su quello americano) ha preferito far gravare sulle banche-reti nuovi costi per circa 3 miliardi di euro a beneficio della “compliance” (MiFID I e II), invece di imporre alle stesse – perché di imposizione si è trattato, in forza di una direttiva europea – investimenti in formazione professionale e commerciale, in strumenti interni di vigilanza, nella regolamentazione di un contratto unico di lavoro (mandato unico di settore) e infine nel passaggio generazionale, che si sta cominciando ad attuare solo da poco e che richiederà ulteriori e sostanziosi investimenti da parte delle reti e delle capogruppo.
Nel caso delle reti di consulenza finanziaria, per esempio, questa metafora risulta essere davvero “azzeccata”, poichè il sistema finanziario europeo, pur di primeggiare nel mondo (in particolar modo su quello americano) ha preferito far gravare sulle banche-reti nuovi costi per circa 3 miliardi di euro a beneficio della “compliance” (MiFID I e II), invece di imporre alle stesse – perché di imposizione si è trattato, in forza di una direttiva europea – investimenti in formazione professionale e commerciale, in strumenti interni di vigilanza, nella regolamentazione di un contratto unico di lavoro (mandato unico di settore) e infine nel passaggio generazionale, che si sta cominciando ad attuare solo da poco e che richiederà ulteriori e sostanziosi investimenti da parte delle reti e delle capogruppo. Naturalmente, una rivoluzione così epocale – per molti addetti ai lavori si è trattato invece di una gravissima “involuzione” – non poteva non avere effetti collaterali di grande incisività sul modo di concepire la professione del consulente finanziario. Infatti le due MiFID, imponendo a tutte le società mandanti e ai gruppi bancari un sistema basato sulla ossessiva osservazione delle regole di compliance, sembrano essere state costruite senza tener conto della funzione fondamentale del consulente quale educatore finanziario. In pratica, chi l’ha concepita sembra aver mandato a tutto il sistema un messaggio “politico” di questo tipo: “continuate a fare ciò che volete, basta che le carte siano a posto!”.
Naturalmente, una rivoluzione così epocale – per molti addetti ai lavori si è trattato invece di una gravissima “involuzione” – non poteva non avere effetti collaterali di grande incisività sul modo di concepire la professione del consulente finanziario. Infatti le due MiFID, imponendo a tutte le società mandanti e ai gruppi bancari un sistema basato sulla ossessiva osservazione delle regole di compliance, sembrano essere state costruite senza tener conto della funzione fondamentale del consulente quale educatore finanziario. In pratica, chi l’ha concepita sembra aver mandato a tutto il sistema un messaggio “politico” di questo tipo: “continuate a fare ciò che volete, basta che le carte siano a posto!”. E’ il problema, che questa testata giornalistica evidenzia da tempo, della “
E’ il problema, che questa testata giornalistica evidenzia da tempo, della “
 In un simile scenario, l’industria del risparmio gestito ha reagito in modo del tutto logico, e cioè tagliando i costi per mettere in equilibrio il proprio conto economico, altrimenti destinato alla soccombenza per via degli ingenti investimenti imposti soprattutto dalla MiFID II. E siccome i margini di ricavo dei consulenti sul risparmio gestito erano già stati gradualmente tagliati (di circa il 50%) dopo la MiFID I, le reti hanno dovuto allontanare alcune migliaia di “consulenti sherpa” che avevano l’unico difetto di trovarsi con il portafoglio dal valore sbagliato nel momento storico sbagliato.
In un simile scenario, l’industria del risparmio gestito ha reagito in modo del tutto logico, e cioè tagliando i costi per mettere in equilibrio il proprio conto economico, altrimenti destinato alla soccombenza per via degli ingenti investimenti imposti soprattutto dalla MiFID II. E siccome i margini di ricavo dei consulenti sul risparmio gestito erano già stati gradualmente tagliati (di circa il 50%) dopo la MiFID I, le reti hanno dovuto allontanare alcune migliaia di “consulenti sherpa” che avevano l’unico difetto di trovarsi con il portafoglio dal valore sbagliato nel momento storico sbagliato. Tutti radiati per irregolarità o dimissionari volontari? Naturalmente no: i consulenti espulsi per aver commesso atti irregolari e/o illegali sono davvero pochi, a dimostrazione di un contesto professionalmente sano. E allora, a cosa si deve un numero così alto di fuoriuscite, quanti sono i “consulenti-sherpa” sacrificati sull’altare della massima raccolta e del portafoglio medio più alto possibile, non degni di essere assistiti con sforzi straordinari (da ripagare in futuro) nel loro percorso di crescita? Siamo sicuri che nemmeno qualche centinaio di loro non fosse meritevole di un supporto straordinario tale da evitare la fuoriuscita dal mercato? E’ così grave che un consulente possa voler vivere con un portafoglio clienti dal valore di 8-12 milioni di euro, assicurando comunque alla società mandante un lavoro di qualità e una immagine adeguata? Perché non si è tenuto in conto che questi professionisti, esattamente come gli sherpa nell’ambiente delle alte vette, erano perfettamente adattati nel sistema finanziario italiano e che per loro sarebbe stato difficile trovare una differente posizione lavorativa?
Tutti radiati per irregolarità o dimissionari volontari? Naturalmente no: i consulenti espulsi per aver commesso atti irregolari e/o illegali sono davvero pochi, a dimostrazione di un contesto professionalmente sano. E allora, a cosa si deve un numero così alto di fuoriuscite, quanti sono i “consulenti-sherpa” sacrificati sull’altare della massima raccolta e del portafoglio medio più alto possibile, non degni di essere assistiti con sforzi straordinari (da ripagare in futuro) nel loro percorso di crescita? Siamo sicuri che nemmeno qualche centinaio di loro non fosse meritevole di un supporto straordinario tale da evitare la fuoriuscita dal mercato? E’ così grave che un consulente possa voler vivere con un portafoglio clienti dal valore di 8-12 milioni di euro, assicurando comunque alla società mandante un lavoro di qualità e una immagine adeguata? Perché non si è tenuto in conto che questi professionisti, esattamente come gli sherpa nell’ambiente delle alte vette, erano perfettamente adattati nel sistema finanziario italiano e che per loro sarebbe stato difficile trovare una differente posizione lavorativa? Qualunque sia la risposta razionale a queste domande, bisogna evidenziare che tali scelte hanno determinato un altro effetto collaterale della contrapposizione tra “scalatori e sherpa”: nel 2023 le reti di consulenza finanziaria italiana stanno soffrendo una evidente stagnazione dei reclutamenti. Questo accade certamente per via del disastroso andamento dei portafogli dei clienti a seguito della contemporanea debacle degli investimenti azionari e obbligazionari (quando un portafoglio è in perdita pesante è difficile per un consulente finanziario convincere un cliente a smobilitare le posizioni e rendere reali i deflussi), ma soprattutto perché la professione del consulente finanziario “Mifid-esecutore” non attira più i giovani talenti, i quali preferiscono altre professioni liberali, magari all’estero, pur di non correre il rischio di fare la fine dei tantissimi sherpa – quante migliaia negli ultimi dieci anni? Assoreti non lo dice – che si sono persi per strada.
Qualunque sia la risposta razionale a queste domande, bisogna evidenziare che tali scelte hanno determinato un altro effetto collaterale della contrapposizione tra “scalatori e sherpa”: nel 2023 le reti di consulenza finanziaria italiana stanno soffrendo una evidente stagnazione dei reclutamenti. Questo accade certamente per via del disastroso andamento dei portafogli dei clienti a seguito della contemporanea debacle degli investimenti azionari e obbligazionari (quando un portafoglio è in perdita pesante è difficile per un consulente finanziario convincere un cliente a smobilitare le posizioni e rendere reali i deflussi), ma soprattutto perché la professione del consulente finanziario “Mifid-esecutore” non attira più i giovani talenti, i quali preferiscono altre professioni liberali, magari all’estero, pur di non correre il rischio di fare la fine dei tantissimi sherpa – quante migliaia negli ultimi dieci anni? Assoreti non lo dice – che si sono persi per strada. In una congiuntura simile, in cui si approssima un periodo di forti decisioni per l’intero settore industriale del risparmio gestito, le reti devono decidere se adottare la stessa fredda strategia degli ultimi quindici anni, oppure far leva sugli enormi utili conseguiti in questi anni per investirne una parte – preferibilmente non miserevole – conducendo tutti i consulenti di oggi verso la vetta, e facendo in modo che nessuno di loro venga più lasciato indietro.
In una congiuntura simile, in cui si approssima un periodo di forti decisioni per l’intero settore industriale del risparmio gestito, le reti devono decidere se adottare la stessa fredda strategia degli ultimi quindici anni, oppure far leva sugli enormi utili conseguiti in questi anni per investirne una parte – preferibilmente non miserevole – conducendo tutti i consulenti di oggi verso la vetta, e facendo in modo che nessuno di loro venga più lasciato indietro. 
 Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un
Pertanto, occorreva un aggiornamento della disciplina, e l’occasione è scaturita da un  l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il
l’assegno è dovuto in funzione “assistenziale” – ossia per le esigenze di puro sostentamento del coniuge più debole – la convivenza ne determina automaticamente l’estinzione; se la finalità è di tipo “compensativo“, lo status di convivente è irrilevante di fronte alla circostanza che il  La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata.
La Corte, però, anche in questa occasione ha peccato di quella tipica indeterminatezza che, come un virus inarrestabile, si trasmette poi ineluttabilmente alle decisioni dei tribunali di merito, per i quali sarà molto difficile adesso determinare l’entità proporzionale della “compensazione” senza commettere errori o senza dover applicare nuove e arbitrarie prassi – molto comode, però – con cui regolare sbrigativamente le questioni. Tutto ciò, naturalmente, con l’inevitabile seguito di ricorsi giudiziali – che tra qualche anno potrebbero richiedere un ulteriore richiamo alle Sezioni Unite – che difficilmente riceveranno una risposta adeguata. Ne cito alcune, solo a titolo di esempio:
Ne cito alcune, solo a titolo di esempio: – Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile?
– Se il presupposto dell’assegno compensativo è l’aver contribuito, con il proprio sacrificio, alla creazione di patrimonio da parte dell’altro coniuge, qual è la forza misteriosa che impedisce di misurare con esattezza l’entità di tale contributo, dal momento che il patrimonio creato ex novo è facilmente misurabile? La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, pertanto, solo apparentemente ha rimesso le cose al loro posto. In realtà – com’è tipico costume della Giustizia Civile italiana in tema di famiglia – essa ha risolto un problema e ne ha creato altri dieci, soprattutto per i coniugi ben patrimonializzati, che potrebbero essere gravati, da oggi in poi, di un assegno divorzile di proporzioni inusitate e durata indeterminata (o determinata in modo frettoloso e inesatto). Per non citare il fatto che una tale pronuncia amplifica ancora di più le differenze – ormai inaccettabili dal punto di vista sociale – tra le tutele prestate dall’Ordinamento alle 

 Dal punto di vista patrimoniale, nella famiglia di fatto manca una normativa assimilabile a quella dettata per i
Dal punto di vista patrimoniale, nella famiglia di fatto manca una normativa assimilabile a quella dettata per i  Dal punto di vista regolamentare, il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, attraverso la stipula di un atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, nel quale è possibile indicare il luogo di residenza della coppia, disciplinare l’uso della casa adibita a residenza comune, scegliere il
Dal punto di vista regolamentare, il contratto di convivenza deve essere redatto nella forma scritta, attraverso la stipula di un atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale, nel quale è possibile indicare il luogo di residenza della coppia, disciplinare l’uso della casa adibita a residenza comune, scegliere il 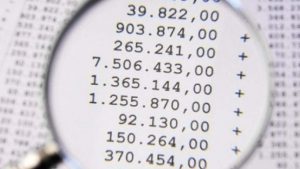 l’unione con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, non ha avuto la possibilità di optare per un regime di comunione o di separazione di beni, per cui le regole di divisione di un
l’unione con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, non ha avuto la possibilità di optare per un regime di comunione o di separazione di beni, per cui le regole di divisione di un  Questo accade perché le somme depositate si suppongono destinate a sopperire i bisogni comuni, e chi le ha depositate non può chiederne la restituzione, salvo pretendere il rimborso delle somme spese dall’altro convivente a titolo personale, ma solo entro il limite della quota del 50%, poiché ciascun cointestatario è in teoria titolare nella misura del 50% del rapporto di
Questo accade perché le somme depositate si suppongono destinate a sopperire i bisogni comuni, e chi le ha depositate non può chiederne la restituzione, salvo pretendere il rimborso delle somme spese dall’altro convivente a titolo personale, ma solo entro il limite della quota del 50%, poiché ciascun cointestatario è in teoria titolare nella misura del 50% del rapporto di  Infine, c’è un altro aspetto molto delicato da tenere in grande attenzione. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate i due conviventi more uxorio sono considerati come dei perfetti estranei tra loro, e pertanto un elevato numero di bonifici bancari da un conto all’altro esporrebbe la coppia ad un rischio di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe voler accertare la natura dei bonifici al fine di scongiurare che gli stessi possano derivare da redditi non dichiarati.
Infine, c’è un altro aspetto molto delicato da tenere in grande attenzione. Infatti, per l’Agenzia delle Entrate i due conviventi more uxorio sono considerati come dei perfetti estranei tra loro, e pertanto un elevato numero di bonifici bancari da un conto all’altro esporrebbe la coppia ad un rischio di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale potrebbe voler accertare la natura dei bonifici al fine di scongiurare che gli stessi possano derivare da redditi non dichiarati.




 “comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di
“comunione residuale” perché non consumato. Pertanto, per evitare una liquidazione del conto corrente cointestato al 50% con il coniuge B, A dovrebbe dimostrare che il denaro in esso versato è un bene “personalissimo”, cioè proveniente da somme di  Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di
Per questo motivo la confusione patrimoniale per “via affettiva” genera in regime di comunione effetti a volte devastanti – si pensi al malcostume diffuso di  C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della
C’è da dire che il denaro personalissimo detenuto nel conto cointestato e non consumato è destinato, al momento della separazione, alla comunione residuale, per cui sarà necessario prelevare da esso, prima della  Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la
Fin qui i problemi che nascono nei conti correnti. Il regime di comunione dei beni, però, può produrre effetti fastidiosi anche in presenza di un conto corrente personale di un coniuge con delega all’altro coniuge. Serviamoci di un esempio pratico, e supponiamo che sul conto del coniuge A confluisca una somma derivante dall’eredità di uno dei suoi genitori. Ebbene, qualora su quel conto il coniuge B ha una delega ad operare, la  Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in
Ma c’è di più. Infatti, nell’esempio considerato potrebbe accadere che tra la ricezione dell’eredità in denaro e il momento della separazione siano trascorsi molti anni, e che nel corso del matrimonio – per qualunque motivo – il conto corrente originario sia stato chiuso e la liquidità sia stata trasferita in un altro conto e, successivamente, investita in 

 Con il Patto di famiglia, l’
Con il Patto di famiglia, l’
 Dal punto di vista della
Dal punto di vista della 
 Il Trust risulta utile, per esempio, quando nei rapporti tra imprenditori si verificano situazioni di “stallo decisionale”, in cui i soci con pari peso amministrativo hanno due visioni diametralmente opposte sulla soluzione da adottare relativamente ad un evento della vita aziendale, e non si riesce così a raggiungere una maggioranza per l’una o per l’altra decisione o, peggio ancora, non si riesce a mettere in atto ciò che è stato deciso in assemblea perché uno dei soci non adempie. In casi come questi – molto simili ad un dissidio da separazione coniugale, a ben vedere – il Trust può risolvere lo stallo derivante dall’inadempimento del singolo socio poiché il trustee, che è un soggetto terzo con specifiche competenze in campo societario, in caso di mancanza di istruzioni congiunte può votare a sua discrezione in funzione di quello che ritiene essere l’interesse della società oppure, a mali estremi, promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società.
Il Trust risulta utile, per esempio, quando nei rapporti tra imprenditori si verificano situazioni di “stallo decisionale”, in cui i soci con pari peso amministrativo hanno due visioni diametralmente opposte sulla soluzione da adottare relativamente ad un evento della vita aziendale, e non si riesce così a raggiungere una maggioranza per l’una o per l’altra decisione o, peggio ancora, non si riesce a mettere in atto ciò che è stato deciso in assemblea perché uno dei soci non adempie. In casi come questi – molto simili ad un dissidio da separazione coniugale, a ben vedere – il Trust può risolvere lo stallo derivante dall’inadempimento del singolo socio poiché il trustee, che è un soggetto terzo con specifiche competenze in campo societario, in caso di mancanza di istruzioni congiunte può votare a sua discrezione in funzione di quello che ritiene essere l’interesse della società oppure, a mali estremi, promuovere la convocazione di un’assemblea per la messa in scioglimento della società.








